Sportivi eclettici
Simone Oggioni
Sei sono le parti del discorso: l’esordio, con il quale si capta la benevolenza dell’uditorio, l’esposizione dei fatti, la posizione che si intende prendere, le argomentazioni a favore e contro. Infine, dopo aver riassunto gli elementi anteriori, il sollecito alle emozioni del pubblico.
Naturalmente, in questo breve scritto non intendo prendere in considerazione questa metodologia. Ciò di cui ho intenzione di occuparmi, invece, è una narrazione in sequenza di episodi che testimoniano, in termini sportivi, la mia ecletticità.
Chi nell’arte o nella scienza non segue un determinato sistema o indirizzo, ma sceglie e armonizza i principi che ritiene migliori, viene definito eclettico. Io credo, in tal senso, di potermi definire uno “sportivo eclettico”. Mi sono cimentato, infatti, in diverse discipline e, pur senza eccellere in nessuna di queste, ho sempre tentato di attingere “il meglio” da ogni esperienza, senza preconcetti e rigidi schematismi mentali. Un po’ per vocazione, un po’ per la voglia di provare nuovi sport, non ne ho mai praticato uno in particolare ma, in compenso, ne ho provati tanti.
Nella provincia di Milano, negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, non c’era né una grande attenzione allo sport né, come oggi, una capillare presenza di società sportive sul territorio. L’orientamento e gli stimoli a migliorare ci arrivavano, quindi, direttamente dagli “eroi” che guardavamo in televisione.
Il tennista autodidatta
La mia prima “attrazione fatale” è stata nei confronti del Tennis. In realtà, devo confessare che, non avendo mai preso lezioni individuali, ho appreso i fondamentali della tecnica osservando attentamente alla televisione le gesta e i rituali dei miei idoli tennistici: per questa ragione, ogni tanto mi sentivo obbligato ad eseguire il rovescio bimane con la mia slazenger, anche se non ve n’era la necessità. Tra i vari suggerimenti e consigli che ci venivano dati dagli adulti o dagli amici che assistevano alle partite, ne ricordo uno in particolare: “il tennis è uno sport individuale che ti porta a raggiungere e a mantenere un impeccabile self-control”. Una volta, durante un lungo game giocato contro un “pallettaro” da fondocampo, cercai di tenere bene a mente questo monito. Infatti, dopo che il miope giudice-arbitro appollaiato sul trespolo mi aveva chiamato out ben tre palline di fila, per non spezzargli la racchetta sulla testa decisi, con perfetto aplomb, di frantumarla per terra decretando così contemporaneamente la sospensione e la fine dell’incontro.
Immancabilmente, dopo aver seguito in TV la finale di Wimbledon o del Roland Garros (mitica quella del 1981 tra Ivan Lendl e Björn Borg), scattava tra me e i miei amici la competizione e il desiderio di emulare le prodezze di quei grandi campioni. Una partita durava in media 18 set e il match sarebbe continuato per tutto il giorno se la nostra trance agonistica non fosse stata interrotta dalla voce della mamma che, dal focolare casalingo, urlava i nostri nomi prolungandoli sulle vocali: «Simoneeee! C’è prontoooo!!!»
Condividendo la mia passione per la racchetta, mamma e papà mi iscrissero ad una settimana di scuola di tennis organizzata dal giornalino Topolino nel pavese. Contornato da “fighetti” che avevano preso ore e ore di lezioni private, mi resi conto ben presto che quasi tutti mostravano un’impostazione e una tecnica nettamente superiore alla mia da autodidatta (“impugnatura semiwestern, eastern o continental? Questo è il problema!”). Nonostante tali carenze, durante le partite del Torneo organizzato al termine dello stage, mi presi un’insperata rivincita morale e materiale aggiudicandomi tra l’incredulità generale la medaglia d’argento. Giocare sulla terra rossa sicuramente mi avvantaggiò, perché il fondo in terra battuta era molto più lento di quello dei terreni in cemento dove giocavo abitualmente e ciò mi consentiva di arrivare sulla palla col tempo giusto sopperendo con la grinta e la tenacia alle lacune propriamente tecniche.
Il calcio come metafora
Il calcio è uno sport di squadra nel quale si affrontano due squadre composte ciascuna da undici giocatori. Il gioco, che si pratica, di preferenza, all’interno di un campo erboso rettangolare dotato di due porte, è regolamentato da una serie di norme codificate dall’Intenational Football Association Board (IFAB). L’obiettivo è quello di segnare più punti (detti goal o reti) dell’avversario, facendo passare il pallone sferico fra i pali della porta avversaria.
A volte, le definizioni di Wikipedia sono veramente tristi e aride. Il calcio è un’altra cosa. È poesia, arte, improvvisazione, regole scritte e non scritte dettate da sentimenti come l’onore, la dignità, il rispetto e l’orgoglio.
Con la mia famiglia, ci eravamo trasferiti da Milano ad Arese nei primi anni settanta del secolo scorso e questo piccolo centro urbano alle porte della metropoli mi sembrò, da subito, un luogo fiabesco. All’età di nove anni mi resi conto, infatti, di aver avuto una fortuna incredibile: un campo da calcio a 7 all’interno del Villaggio, tutto per me. Addirittura, a differenza di ciò che accadeva a Milano dove trovare uno spiazzo erboso aveva del miracoloso, si notava la presenza di un’erbetta soffice diffusa su tutto il perimetro di gioco. Inutile dire che il “miracolo” durò solo per i primi tre mesi. La massa di promettenti calciatori che vi sgambettavano giorno e notte consumò in un baleno sia il centro del campo che le due aree.
Le partite di pallone erano interminabili. Iniziavano al mattino e finivano a tarda sera solo perché il calar del sole non ti permetteva né di riconoscere i tuoi compagni né tanto meno di vedere la palla, altrimenti sono sicuro che sarebbero durate per mesi. Un numeroso gruppo di ragazzi, con degli adulti volontari che fungevano da allenatori, percorreva ogni giorno in lungo e in largo l’area da gioco. Uno di questi, il portiere della squadra, era soprannominato “Lasciala scorrere” ed aveva una dote particolare. Ogni volta che arrivava un tiro da fuori, gridava a squarciagola: “Lascialaaaa scorrereeee!”. La difesa, paralizzata dal grido belluino, si fermava improvvisamente confidando nelle capacità dell’ultimo difensore che, infatti, rimaneva immobile sino a che la palla non rotolava lemme lemme in rete. In questo modo prendemmo un’infinità di goal ma non ci demoralizzavamo mai e ogni domenica ci si ritrovava sempre sul campetto.
Una vittoria o una sconfitta lasciano comunque dentro l’animo il “sapore” della vita.
Il mio principale riferimento calcistico era il “mitico” Zio Aldo, mediano d’altri tempi che risolveva le partite con una “minnella” da centrocampo o con una punizione ben piazzata. Sin da piccoli, io e mio fratello lo seguivamo durante i suoi incontri a Settimo Milanese, Seguro e Sedriano. Era il nostro top player, il playmaker arretrato da cui partivano tutte le azioni dell’équipe di cui era capitano. Ogni domenica pomeriggio, lo Zio ci portava a San Siro per vedere la sua squadra preferita, l’Inter. Nonostante questo surrettizio tentativo di imprinting calcistico, i nostri piccoli cuori continuarono a battere lo stesso a ritmo rossonero.
Tornando alle nostre esperienze aresine, mentre ci recavamo al campo, prima della partite casalinghe del Trofeo città di Arese, ci capitava spesso di ascoltare le celebri massime della signora Pina che improvvisava delle vere e proprie invenzioni grammaticali coniando nuovi modi di dire e nuove parole: «Ragazzi quando andate a giocare nei campi state attenti a quei tossici indipendenti, se poi andate vicino alla fattoria ci sono tutti i cavalli allo stato ebraico che possono diventare pericolosi. State attenti ragazzi, una volta un bambino in una partitella si è fatto male ed è arrivata subito un’ambulanza da Santa Maria Rosa a sirene spietate che lo ha portato via...» Ci trattenevamo a stento dal ridere per una forma di rispetto verso le persone più grandi ma, quando eravamo fra di noi, ci venivano fuori ad una ad una. Ah sì... dimenticavo: «Per favore, mi passi il cuoci bevande.»
La domenica, dopo la partita, ci si cambiava e si andava a Messa sempre all’interno del villaggio dove un salone adibito a Chiesa ospitava tutti fedeli. C’era chi arrivava con le scarpe da calcio ancora sporche, chi non sarebbe mai andato a Messa ma, solo perché tutta la squadra ci andava, si sentiva moralmente spinto a partecipare.
Il Villaggio, concepito urbanisticamente quasi come una cellula abitativa indipendente, con all’interno la residenza principale, le attrezzature sportive, la parte commerciale e il luogo di culto prima menzionato, ha rappresentato un modello che non ha retto nel suo insieme sino ai tempi d’oggi, ma ha subito delle modificazioni. Le attrezzature sportive sono evidentemente rimaste, anche se, per effetto del calo demografico, sono meno frequentate rispetto agli anni ottanta. La Chiesa è stata costruita all’esterno e la parte commerciale pian piano si è volatilizzata.
Il calcio, insomma, metaforicamente ha rappresentato la chiave che ha aperto e agevolato le relazioni personali fra i ragazzi aresini, garantendo alle compagnie disseminate nei vari villaggi, spesso chiusi in se stessi, un’occasione per stringere amicizie fuori dalle quattro mura scolastiche e un luogo “fisico” in cui confrontarsi e socializzare.
Al di là di tutto, la mia passione nei confronti del football è comunque rimasta immutata anche se mi rendo conto che, a causa del notevole calo di dinamismo, le nostre partite di calcio si stanno trasformando in partite a scacchi. Infatti, le frasi che si sentono in campo non sono più “lanciamela sulla corsa” oppure “scatta sulla fascia che ti lancio” ma sono diventate “B4 in C2. Arrocco.”
Due anni fa, mentre sostavamo nelle vicinanze del desolato campetto del Siolo con mio fratello Flamo e Giorgio, abbiamo deciso di affiggere un cartello all’entrata della portineria: “Derby Milan-Inter delle vecchie Glorie. Domenica in campo ore 10.00”. Non ho ancora ben capito come sia potuto accadere ma tutta la “squadra del Siolo” si è presentata in campo come se non fossero trascorsi quasi trent’anni.
Di prima mattina, un piccolo distaccamento nerazzurro era stato avvistato mentre stendeva una mega bandiera nerazzurra dietro la porta nord del mitico campetto del Siolo. Subito dopo, i rossoneri rispondevano, ristabilendo gli equilibri, con altrettante bandiere esposte sulla porta sud.
Il momento cruciale stava per arrivare. Erano le nove e mezza e si vedevano comparire personaggi d’altri tempi vestiti con pantaloncini anni ottanta e scarpe “Tepa Sport” ben conservate. Era comparso anche un fantasma con maglia originale della squadra perfettamente stirata e capigliatura inalterata, esattamente come trent’anni fa.
Anche se non ci si vedeva da molto tempo, abbiamo immediatamente riprovato le stesse sensazioni di amicizia fraterna di allora. In difesa, il mitico Gianmarco, un colosso insormontabile in fase d’interdizione grazie alla sua capacità di adottare rigide marcature da baskettaro. Edo e Alex, in forma eccezionale, spaziavano trotterellando per tutto il centrocampo, Rillo correva più veloce di un ventenne, Antonello sulla fascia, la punta Claudio, i centrocampisti Giancarlo e Luca, i fratelli Simo e Flamo e poi “Claud and Paul”, Sergio e Nicolino, Giorgio e Renato.
In porta due certezze. Non più “Lasciala scorrere” ma Nico per l’Inter e Alessandro per il Milan.
Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fischio d’inizio.
La palla arriva al Carlo, stiramento e sostituzione immediata: «Raga è stato bello ma ora guardo la partita da fuori. A mangiare però, dopo, ci vengo lo stesso!»
Questo è il vero spirito del calcio. Oltre alla partita, c’è sempre un momento di ristoro in compagnia. Ah, dimenticavo... Milan 3 Inter 1.
La moto e via Nuvolari
“O motociclista... lasci alle spalle il tempo
ascoltando il vento, che sui tratti del tuo viso passa veloce,
inebria le tue certezze e alimenta i sogni...”
“O motociclista... lasci alle spalle il tempo
ascoltando il vento, che sui tratti del tuo viso passa veloce,
inebria le tue certezze e alimenta i sogni...”
Un’altra delle mie passioni sportive è stata il motociclismo. Ho passato giornate intere nel box a smontare e rimontare carburatori e marmitte immedesimandomi in Fonzie di Happy Days. Dopo ore e ore trascorse nel garage, nel momento in cui iniziavo a pensare, sul serio, che la moto avesse un’anima e dei sentimenti, mi rendevo conto però che forse era il caso di andare a dormire e di organizzare per l’indomani una bella partita di calcio con gli amici.
Percorrendo ad Arese la famosa via Tazio Nuvolari, via chiusa in prossimità della storica Ditta Alfa Romeo, mi immaginavo di essere su una pista prova ufficiale dove poter spingere oltre il limite il mio roboante ciclomotore smarmittato. A volte, dopo aver inanellato giri su giri al massimo della potenza, tipo MotoGP del Mugello, dovevamo allontanarci dalla nostra pista motomondiale privata con una certa celerità, onde evitare l’arrivo della pula allertata dagli inquilini dei caseggiati sorti nei dintorni.
Questa passione motociclistica mi è rimasta nel cuore e con Silvia, nell’estate del 1994 e in quella del 1995, ci siamo avventurati in Grecia accessoriati solo con una tenda di emergenza, due borse laterali e un bauletto, qualche libro sull’età classica e tanta fantasia. Vacanze indimenticabili durate un mese, in bed and breakfast improvvisati (alcune volte, le signore ci hanno offerto direttamente la loro camera da letto) e a volte in campeggio, attraversando, da Patrasso, tutto il Peloponneso sulla costa occidentale sino a Monemvasia e poi traghettando verso Creta e Rodi per circa tremila chilometri di percorrenza.
Addentrandoci sugli sterrati dell’entroterra, una sera ci imbattemmo casualmente in una sagra di paese dedicata alla raccolta delle olive e, grazie all’incredibile ospitalità greca, fummo trattati come gli ospiti d’onore: ci venne dato il tavolo principale e, dopo esserci uniti alle danze che culminarono con il sirtaki, ci vennero offerte delle prelibatezze culinarie elleniche tra cui la feta con le olive, i souvlákia, la moussakà e abbondanti razioni di ouzo. Eravamo gli unici due motociclisti in giro con il casco in mezzo agli uliveti e i profumi della macchia mediterranea pervadevano l’aria. Talvolta capitava di imbatterci in piccoli casali che emanavano profumini di griglia... una pinzata sul freno e via... poco dopo eravamo sotto un pergolato ad assaporare il retsìna con un maialino cotto alla brace.
Sono certo che il monocilindrico nipponico gioiva nell’effettuare questi viaggi di migliaia di chilometri poiché non dava apparenti segni di cedimento né di fatica. Solo in una giornata particolarmente calda, al termine di un lungo tragitto per visitare Olimpia, sentimmo un odore di bruciato provenire dal retrotreno della moto. Dopo esserci fermati, cominciammo ad ispezionare “la belva” e ci accorgemmo che del “gelato al pistacchio” colava da dietro le borse laterali. Guardando con più attenzione, ci rendemmo conto che ciò che si stava sciogliendo “profumatamente” era la mascherina laterale di color verde della moto entrata in contatto con la marmitta.
Nell’estate del 1995 visitammo, invece, la parte nord della Grecia sino alle meteore, suggestivi monasteri accessibili da terra solo con sistemi ad argano. Durante il viaggio, di tanto in tanto, Silvia sentiva nell’aria profumo di latte e miele. Una breve sosta ci consentiva di assaporare lo giaoúrti locale con miele e noci. Proseguimmo poi verso le “tre dita” e poi giù verso le isole confinanti con la Turchia, tre giorni su un isola, tre sull’altra, sino a Rodi.
Durante gli spostamenti via mare, si usavano piccole imbarcazioni precarie che ondeggiavano tantissimo. Difatti, appena salito in barca, i marinai mi dicevano «Tieni questa corda, e legati la moto perché tra un po’ si balla!» Cominciammo a pensare che era ora di tornare a casa quando, dopo aver rischiato di cadere dalla moto a causa di una forte raffica di vento, esclamai “Malaka!” al posto delle solite imprecazioni in milanese.
Al rientro in Italia, dopo aver trascorso tutti e due i mesi estivi con splendide giornate di sole, percorremmo il tratto autostradale da Pescara a Milano sotto un diluvio incredibile, quasi che “qualcuno” volesse farci sapere che, anche secondo lui, avevamo esagerato.
Le mini-Olimpiadi
Nel Villaggio dove abitavo, una volta terminate le scuole, venivano organizzate delle mini-Olimpiadi. La gara più spettacolare era quella dei 60 metri. Sulla strada asfaltata si tracciavano con il gesso bianco le corsie, le linee di partenza e di arrivo. Con il pensiero rivolto agli atleti dei Giochi olimpici, il classico “Pronti, partenza, via!”, ci vedeva tutti pronti a scattare verso il traguardo. Un dubbio però mi è sempre rimasto. Come faceva la ragazza dal seno prosperoso a batterci sette volte su dieci?
Fra una gara e l’altra, si andava a prendere in giro un mastodontico mastino napoletano di nome Ugo. Sicuri di non essere raggiunti, da dietro la recinzione che contornava il suo giardino, si facevano gestacci a ripetizione fino a fare alterare tutti i neuroni del potente molossoide.
Grazie al passaparola, tra i ragazzi del villaggio era iniziato cosi il “rituale del cane Ugo”. Tale consuetudine veniva alimentata anche durante l’intervallo delle partite di calcio. Un pomeriggio, il centrale Dodo disse «Vado da Ugo e torno subito.» Non tornò, invece, per tutto il giorno: mentre eseguiva il solito repertorio collaudato di sberleffi rivolti al potente cane, non si era accorto del cancelletto pedonale completamente aperto. In tale circostanza, occorre dire che il “prode” Dodo mise a profitto gli allenamenti atletici dei giorni precedenti riuscendo ad evitare miracolosamente che, al termine di una vera e propria corsa a ostacoli, le potenti mascelle partenopee si avventassero sul suo deretano.
Tratti in salvo da un veliero
battente bandiera panamense
battente bandiera panamense
Ed ecco i milanesi che affrontano il mare e si approcciano agli sport acquatici.
Mi trovavo in Corsica per le vacanze estive e, spinto dalla poesia del mare e dalla brezza del vento, ho iniziato a frequentare un breve corso di catamarano con istruttori che illustravano in francese piacevoli geometrie marine, mentre io rispondevo in un fluente milanese stretto. Ci si capiva perfettamente, anche se non so bene come, aiutati forse dalle assonanze fonetiche simili. Ed è cosi che, al termine del corso accelerato di “lupo di mare”, mi sentii pronto ad affrontare il fragore dei marosi e le insidiose correnti còrse, sospinto dal maestrale o dal libeccio.
Siamo, probabilmente, fra i rarissimi velisti che sono riusciti a scuffiare al contrario e senza particolari raffiche di vento. Una mattina, in quel di Porto Pollo a sud della Corse, ho voluto iniziare un nuovo marinaio che, fino a quel momento, non aveva mai retto più di tanto il mare: mio fratello. A metà del golfo, in prossimità del mare aperto, accarezzati da una lieve brezza, mi ero posizionato in poppa con i comandi sulla randa del soprannominato Katamaranza. Flamo, essendo alla prima uscita, aveva responsabilità e gestione del fiocco di prua.
Dopo qualche minuto di navigazione, scrutando l’orizzonte come uno dei personaggi di Jerome K. Jerome, mi resi conto che vedevo salire sempre più l’uomo collocato a prua, mentre io scivolavo sempre più in basso.1 “Non ci sono problemi, ma soluzioni”, dicevo a me stesso con perfetto autocontrollo. In questo susseguirsi di eventi, ci cappottammo dolcemente all’indietro, scivolando lentamente in mare con un senso di disorientamento e senza capirne la causa.
Tratti in salvo da un veliero battente bandiere panamense, scoprimmo con nostro grande rammarico che i noleggiatori dell’imbarcazione si erano dimenticati di chiudere i tappi di scarico degli scafi e, per tale motivo, avevamo imbarcato acqua per tutta la navigazione.
1. J.K. Jerome, Tre uomini in barca, Milano, Rizzoli, 1978.
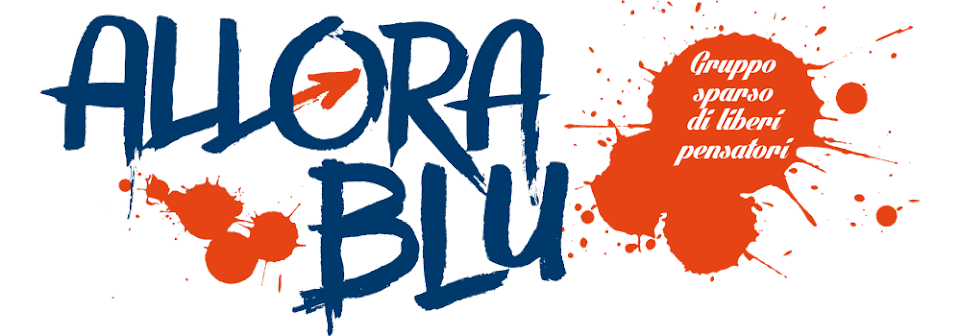

Nessun commento:
Posta un commento