(prima parte) (seconda parte)
Una notte piuttosto particolare
Potevano essere le quattro o le cinque del mattino, ma nessuno potrà mai dimenticare la figura ciondolante di Vitellozzo davanti al camino di pietra nel vecchio mulino dei genitori di Bicio. Una cascata di capelli lunghi e neri non riusciva a nascondere la sua faccia obliqua immersa dentro una scatoletta di tonno all’olio d’oliva che teneva in una mano. Con l’altra cercava di adescare gli ultimi tranci, ormai ridotti in poltiglia, con una fetta di salame. Il pizzetto che gli circondava la bocca lanciava riflessi giallognoli che s’illuminavano fin sopra la camicia bianca, pezzata da aloni di grasso. Le gambe divaricate, come avrebbe fatto Sonny Liston sul ring contro Cassius Clay, attutivano un pochino il movimento oscillatorio del tronco, ma ogni vibrazione provocava un terremoto nella scatoletta e l’olio colava lungo le sue braccia come una processione.
L’ultimo tuffo del salame aveva portato a galla una bava di tonno che Vitellozzo, in uno spasimo di eccitazione, aveva sollevato al cielo come un trofeo appena conquistato. Due gocce gialle cadute dall’alto stavano solcando la sua fronte quando lui in un gesto trionfale si era cacciato in gola l’ultima fetta, senza neppur togliere la pelle. Aveva dondolato ancora qualche minuto, guardandosi intorno come un cane arrabbiato. Il movimento sussultorio del suo corpo nel frattempo aveva favorito l’esplosione di un fragoroso rutto che aveva buttato giù dalla poltrona il Jolly ancora in uno stato di incoscienza. Quindi, schiacciato da tutto quello che si era calato in corpo, era stramazzato sulle mattonelle di cotto vicino agli ultimi tizzoni di brace del camino, con un ghigno inquietante.
Il vecchio mulino stava appollaiato sulle prime colline dell’entroterra ligure che scivolano dolci nel mare di maggio. Si affacciava sulla piazzetta della piccola chiesa di San Bernardo e da lì, tra i profumi di lentisco e corbezzolo, la cartolina azzurra che appariva all’orizzonte sembrava sfregiata dalla lama di asfalto dell’autostrada. Quasi tutti i venerdì, quando i genitori di Bicio rimanevano a Milano a sbrigare le loro faccende, il vecchio mulino era la meta del dopo-partita; praticamente, il paese dei balocchi.
Verso le 11 di sera, caricati i borsoni nel bagagliaio, la R4 di Pollo tagliava in due la città per raggiungere l’autostrada. Non percorreva la circonvallazione come avrebbero fatto tutti gli altri, perché il Tuttocittà di Pollo aveva le sue tappe obbligate e per nessuna ragione al mondo lui avrebbe derogato alla sua personalissima mappa mentale. Sosta da Gattullo per comprare i croissant per la colazione, pieno di broda all’Agip di piazzale Belfanti, con sosta tecnica ai cessi e quindi via verso il casello, dietro alla Ford di Bicio che aveva caricato il Tita, il Conte e il Rosso, e alla “bianchina” di Zio che viaggiava sempre con il Pelanda e con il Chivas.
Il viaggio in sé era già un’avventura e nessuno poteva giurare che il convoglio sarebbe arrivato a destinazione sano e salvo. Non tanto per le condizioni meccaniche della R4, che Pollo teneva con cura maniacale, quanto piuttosto per lo stato di ebbrezza dell’intero equipaggio, che aspettava solo il venerdì sera per dare libero sfogo ai propri impulsi più primitivi. Il Jolly e Vitellozzo accendevano la prima canna più o meno all’altezza del ponte della Ghisolfa, quando ormai il Lillo era già alla terza lattina di birra, pronta a raggiungere i cadaveri che giacevano sotto i sedili, assieme ai mozziconi di sigaretta.
«Cazzo Lillo, quante volte ti ho detto di non buttare per terra i mozziconi. Quando arriviamo te li faccio ingoiare a uno a uno.»
Pollo non voleva sentire ragione quando si toccava la sua macchina. L’aveva comprata grazie ai soldi messi da parte con i lavoretti che di tanto in tanto faceva alla Fiera e con le consegne sotto il periodo di Natale. «Se invece di rompere i coglioni ti comprassi un portacenere non saremmo qui a discutere,» obiettò Lillo con profondo distacco. «Ma buttali fuori dal finestrino, no?» supplicava Pollo. «Mai, si rovina l’ambiente e poi è vietato dalla legge,» replicò secco Lillo rispolverando il suo antico spirito ambientalista. «Ciccio, passi canna.»
A Gropello Cairoli l’aria dell’abitacolo era già irrespirabile e avrebbe raggiunto livelli di saturazione allo svincoli di Voltri, se non ci fossero stati i rutti di Vitellozzo che l’appestavano ancor di più. «Guarda che stellata, mi ricorda la mia nonna,» disse mentre trafficava con il tabacco e le cartine lunghe. «Da piccolo, in campagna, adoravo passare le notti a guardare il cielo e mia nonna mi raccontava delle storie incredibili, cullandosi sul dondolo sotto la copertina di lana patchwork.»
Una fiammella sentimentale si accese negli occhi obnubilati di Vitellozzo, come se dovesse sprigionare da un momento all’altro una vampata di lacrime. Pollo lasciò scivolare nel vuoto quel momento di languidi ricordi infantili, ma il Lillo con la bocca impastata era sul punto di sfasciare quell’atmosfera da libro cuore. «A me queste cose fanno scoreggiare.» Il Jolly era sprofondato in un sonno chimico, non si sa bene da quanto tempo.
Le macchine sfrecciavano a velocità supersoniche e il mare buio e nero accompagnava l’R4 che trotterellava verso il paese dei balocchi. Bicio e Zio a quell’ora avrebbero già dovuto superare il casello. «Avete sentito la storia di Rocco?» disse all’improvviso Lillo per tenere viva la conversazione, che dopo tre ore di viaggio cominciava a languire, con un colpo di teatro: «Pare sia frocio.» Pollo cercò nello specchietto retrovisore lo sguardo di Vitellozzo. Il Jolly non dava segni di vita. «Ma non dire cazzate!» esclamò come per troncare sul nascere il pettegolezzo. «Io non lo so, non me l’ha mai ciucciato. Me l’ha detto il Chivas,» aggiunse Lillo. «In effetti... io non l’ho mai visto con una donna,» fece Vitellozzo con l’aria di chi scava nei ricordi. «Ma ragazzi, dai. Quante volte abbiamo fatto la doccia insieme nello spogliatoio? Non è vero, ce ne saremo accorti,» insistette Pollo che cominciava a interessarsi all’argomento. «E chissà quante volte ti ha guardato l’uccello,» chiosò Lillo scoppiando in una fragorosa risata che fece svegliare il Jolly di soprassalto. «Che cazzo succede?» riuscì a bofonchiare a mezza voce. «Niente, niente, Rocco ti vuole scopare,» continuò Lillo con la sua risata sguaiata. «Ma che cazzo dici?», scattò il Jolly piantando bene il culo sul sedile della R4. «Massì, in fondo sono cazzi suoi,» riprese Vitellozzo. «Per me non cambia niente. Io mi rollo una canna, in onore di Rocco,» fece Lillo con tono celebrativo. «Contento lui...» aggiunse Pollo. «Preparate il grano, siamo arrivati al casello.»
Verso le due di notte la R4 arrancava sulla stradina che portava al vecchio mulino e di lì a poco ognuno avrebbe potuto testare la propria resistenza al viaggio, all’alcol e alle canne. «Ma siete scemi?» Bicio stava già litigando con il Pelanda e il Chivas che volevano organizzare una partitella davanti alla chiesa di San Bernardo: così, per sgranchirsi le gambe. «Ma non facciamo casino, quattro contro quattro e si arriva a cinque,» disse indulgente il Pelanda. «Ci sono anche i lampioni della chiesa che illuminano il sagrato e guarda che panorama...» aggiunse il Chivas con il tono più soave che conosceva. «Dai ragazzi, non scherziamo, qui stanno tutti dormendo,» supplicò Bicio, che però dovette arrendersi quando Zio, il Tita e il Jolly cominciarono a palleggiare davanti al cortile della chiesetta. «Andate a fanculo. Io vado a preparare gli spaghi.»
Bicio era un grande cuoco e in quattro e quattr’otto mise in piedi una sontuosa cena che avrebbe sfamato persino i più tossici del Parco Sempione. Spaghetti al ragù di coniglio, tagliata di manzo e fiumi di Ormeasco sulla tavola imbandita. Sparsi qua e là per la cucina pezzi di pecorino e fette di salame di Felino, bottiglie di birra a iosa. Insomma, una festa. Finite le cibarie, c’era chi si buttava sul divano a guardare la televisione, chi strombettava il corno antico messo sul davanzale del salone per dare un tocco un po’ retrò all’ambiente, chi ballava intorno al camino.
Ben presto la bolgia esondò oltre le massicce pareti di pietra del mulino e si propagò festosa per le viuzze strette del paese. Vitellozzo e Zio stavano ballando sul tavolo quando sull’uscio apparve la silhouette di Gerda, una tedesca sulla quarantina che però non aveva perso il suo fascino da valchiria. Bicio sbiancò in volto e stava preparando la sua faccia più umile per scusarsi con la vicina. «Abbassate questa cazzo di musica,» gridò all’indirizzo di Chivas e di Lillo, avvicinandosi a testa bassa alla tedesca. Fuori cominciava ad albeggiare e dietro le spalle della tedesca cominciava a formarsi un gruppetto di persone che buttavano gli occhi dentro il vecchio mulino come se si trovassero di fronte a un cataclisma. «No, no, lascia stare,» disse Gerda con un forte accento bavarese, mentre con la mano spalancava definitivamente la porta di legno. «Finalmente un po’ di vita, in questo mortorio,» e si buttò a capofitto nell’atrio dl mulino tra gli sguardi esterrefatti di Bicio e di tutti gli altri. Zio saltò giù dal tavolo e corse incontro alla vestaglia di raso che in controluce stuzzicava ben altri appetiti. Biascicando parole incomprensibili, la prese per mano e la trascinò nel vortice del ballo. Ci provò anche Vitellozzo, ma cadde rovinosamente per terra spaccando un paio di bicchieri.
Fuori intanto, non mancava chi cominciava a bestemmiare per il chiasso, ma la maggior parte degli astanti, quasi tutte ragazze e signore in camicia da notte, era più attratta dal baccanale che usciva dal mulino. Le più audaci non si fecero troppi scrupoli e si buttarono nelle danze, come se fossero davanti a un rito iniziatico. Bicio era stato costretto a tirar fuori le chiavi della cantina e insieme con Lillo e il Pelanda aveva saccheggiato gli scaffali e depredato le migliori etichette che il padre custodiva gelosamente come un tesoro. Il Pelanda stava raccontando la sua vita a un’avvenente vicina che con grande savoir faire sorseggiava un calice di Nebbiolo. Un gruppetto di signore un po’ attempate si erano radunate intorno al bancone della cucina e non davano tregua a Pollo e al Tita che affettavano salami e tocchi di Parmigiano, ma non riuscivano a tenere il passo delle dame ammiccanti. Il Jolly se ne stava seduto sulla poltrona a rollarsi una canna, strisciando sulla coscia di una sbarbata che, appollaiata sul bracciolo, seguiva ammirata le operazioni. Intanto i fiati potenti dei “Kc & the sunshine band” caricavano l’aria viziata del salone e un’iniezione di adrenalina pervase le gambe di Lillo e di Zio che parevano indemoniati davanti alle vestaglie di seta di quelle ballerine piovute dal cielo come un dono divino. Il camino lanciava fiammate di calore che arroventavano l’aria e i corpi bollenti avevano preso a strusciarsi senza pudore.
Gli ultimi tizzoni di brace si stavano spegnendo e nel salone era calato uno strano silenzio che si aggrappava al fumo e agli odori che addensavano ancora l’aria. Vitellozzo stava ancora lì, riverso nei suoi miasmi, e dalle stanze al piano superiore giungeva ormai solo il russare profondo del Tita e del Rosso. La porta del mulino era rimasta spalancata tutta la notte, come una puttana senza vergogna che si gode la brezza del mattino. «Ti preparo un caffè,» disse Bicio a Gerda guardandola negli occhi che si specchiavano appagati nelle prime luci dell’alba davanti al mare azzurro.
***
Con il pallone di cuoio sotto il braccio Napo camminava di bolina per raggiungere il centro del campo ma anche per non togliere gli occhi dalle ragazze dietro la porta. Si muoveva smargiasso davanti ai compagni di squadra finché sfiorò con le dita la palla e lì sentì una leggera scossa. Il contatto della mano sul cuoio del pallone è un’esperienza adulta. È un profumo nascosto nell’ippocampo del cervello, che ogni tanto rispunta nella memoria. È un richiamo maschio, che Napo aveva scoperto per la prima volta qualche settimana addietro alla fine degli allenamenti.
Come tutti i martedì, quando ormai il buio aveva conquistato anche l’ultimo angolo del campetto dell’oratorio e l’umidità della sera cominciava a colare fredda sulla fronte assieme al sudore, Nonno Garella ordinava la fine degli allenamenti con un perentorio fischio. «Tutti sotto la doccia!» gridava con la sua voce pastosa.
«Ma oggi non facciamo la partitella?» protestavano i ragazzi.
«Via, via... tra un po’ la Perissi annuncia l’Almanacco,» tagliava corto il nonno.
«Almeno i rigori, dai...»
«Niente storie: a lavarsi!» e con un fischio definitivo troncava qualsiasi ulteriore ipotesi di proroga.
Tre docce per una dozzina di ragazzi sporchi e sudati hanno sempre rappresentato la media igienica dei campetti agli angoli della città. Dal Gallaratese alla Bovisa, da Quarto Oggiaro fin su quasi al Sempione, tutti gli spogliatoi che avevano ospitato la squadra di Napo avevano tre sole docce. Quelli della parrocchia non facevano eccezione. Mezzo Litro, Pezzey e il Banana non ci pensavano neanche a farsi la doccia lì dentro e, ficcati i loro vestiti dentro il borsone da calcio come capitava, con il giubbotto sopra la maglia sporca e i calzoncini, salutavano l’allenatore e si dissolvevano nel buio verso casa. Nello spogliatoio si sentiva ancora il rumore dei tacchetti d’acciaio sotto il porticato quando Mille Lire e Garella, nudi come in paradiso, cominciavano a spintonarsi e tirarsi “vecchiette” sulle gambe e cazzotti sulle spalle, mentre la Lecca e Napo li prendevano a pallonate. «Tra cinque minuti finisce l’acqua calda,» avvisava esausto il mister seduto sulla panchina con il suo fischietto d’argento tra i denti come fosse un mozzicone di sigaro spento. «Ancora qui? Muovetevi, cialtroni.» Don Antonio era venuto a dare manforte a Nonno Garella e sollevatosi la sottana, con fare risoluto, menava calci su culi nudi che cercavano scampo sotto le docce. Prima di andarsene s’intratteneva per due chiacchiere con l’allenatore e ne approfittava anche per fare quattro palleggi.
Sotto tre docce, quattro sbarbati brufolosi e carichi di ormoni sono uno spettacolo sconsigliato ai minori. Il primo a spintonare fu Napo. La Lecca crollò su Mille Lire, che si afflosciò tra le braccia di Garella. «Parata,» esultò Napo mentre cercava di ingropparsi la Lecca, che arrancava come un’anguilla sulle piastrelle bianche. Garella dettava il ritmo dell’orgia menando il suo biroccio sulla testa di Mille Lire che, ancora in ginocchio, cercava il pertugio tra le chiappe del portiere per infilarci dentro un dito. Erano qualche passo più avanti rispetto allo scherzo della saponetta e la differenza, adesso, si misurava in centimetri. E quando non bastava erano i primi peli del petto a fare la differenza.
Mentre si vestivano Nonno Garella cacciava tutta la muta di palloni dentro la rete di corda. «Stasera dobbiamo andare a gonfiarli, se no domenica non si gioca,» buttò lì tra l’indifferenza generale. «Chi viene con me dai Cioppi?» Questa domanda era ormai diventata un mantra dentro lo spogliatoio. Il mister ci provava a cercare volontari ma, tra improvvisi colpi di tosse, nonne in punto di morte e compiti da finire, ognuno svaniva dietro una scusa. «Ok, stasera viene Napo.»
I Cioppi erano due fratelli gemelli che stavano al Villapizzone. Per fare in fretta, tutto il rione li aveva ribattezzati Cip e Ciop; poi per risparmiare ancora qualche consonante erano diventati i Cioppi. Tutti conoscevano la loro bottega delle bici vicino alla stazione: un ammasso di rottami che riempiva il marciapiede ed esondava sulla carreggiata antistante.
Dentro il locale, telai e ruote appese al soffitto stavano lì con la dignità di una scultura contemporanea, anche se le centinaia di bici affastellate tra il bancone e la vetrina davano una piega piuttosto avanguardista all’ambiente. Sopra il bancone, una lampadina illuminava la foto di Moser alla Parigi-Roubaix.
I due gemelli non si somigliavano affatto: uno nervosetto, scuro e malmostoso; l’altro, il biondino, più guascone e sorridente. Più o meno tutti i martedì sera facevano gli straordinari e tenevano accesa l’insegna del negozio fino a quando Nonno Garella spuntava nell’ombra, accompagnato da un ragazzino che trascinava, dentro un sacco, un mucchio di palloni sgonfi. Il compressore d’aria era stato già piazzato davanti al bancone e, sopra, sull’ago d’acciaio che serviva a gonfiare i palloni, rimbalzava la luce della lampadina come uno spicchio di luna. Il malmostoso trafficava tra palmer e catene sporche di grasso, facendo finta di essere molto occupato, mentre il guascone riempiva Nonno Garella di salamelecchi e qualche volta si spingeva persino a offrirgli una birra. Che il mister rifiutava regolarmente per rispettare il cerimoniale, ma anche per non tirarla troppo per le lunghe.
Napo era stato già altre volte dai Cioppi per gonfiare i palloni ma quella sera, sarà stata l’icona luminosa di Moser o l’odore di mastice che si respirava dentro quel locale un po’ carbonaro, il capitano era piuttosto agitato. Spingeva i palloni a uno a uno verso il Cioppi con una certa risolutezza, anche perché l’ora di cena si avvicinava con una certa fretta. E non aveva nessuna voglia di dare l’ennesimo pretesto alla madre per la solita sfuriata davanti alla zuppa ormai fredda. Aggrovigliandosi nella rete aveva cavato l’ultimo pallone e lo aveva tirato insolente tra le gambe del Cioppi come un rigore. «Uè Biscela! Caga o lassà liber el bus.» Era un guascone, e non stava certo lì fino alle sette di sera per farsi prendere per il culo dall’ultimo pirletta della giornata. La risata esagerata di Nonno Garella poi rendeva ancor più indecifrabile la lettura della situazione. Incazzarsi o stare calmi? L’eterna esitazione davanti a un bivio.
Napo aveva messo il Cioppi nel mirino, puntando al cuore. Ma l’immagine che gli era tornata negli occhi come un lampo lo aveva confuso ancor di più. Non era un’iniezione d’aria, era un biberon nelle mani di un papà. Accovacciato sulle ginocchia, con la delicatezza di una balia, il Cioppi aveva preso in braccio la palla e la accarezzava come fosse un cucciolo da proteggere. E, per rendere meno doloroso l’intervento, aveva alzato i suoi occhi grigi verso Nonno Garella per catturare il suo sguardo, prima di infilare l’ago nella palla. Mentre raccontava le ultime imprese del Pessina al mister, accanito tifoso di ciclismo e della Vigor, premeva con delicatezza il ventre molle del cuoio fino a restituirgli il suo intimo fascino.
«Mister, mi scusi. Ma che cos’ha detto il Cioppi? Io mica l’ho capito, sa?» Mentre camminavano nei vialetti bui del parco per far ritorno a casa, Nonno Garella non aveva spiaccicato una parola. E quando cominciavano a spuntare le luci dei portoni, Napo aveva colto la palla al balzo per rompere quell’enigmatico silenzio, con una curiosa inflessione meneghina. «Certo che son ben strani quei due... Il biondo, poi, mi fa morire: non si capisce nulla quando parla e non vuole mai una lira per il disturbo.» Il lamento dell’allocco nascosto tra le betulle del parco rendeva il monologo di Napo quasi surreale. «La sa una cosa? Mi ha colpito molto come faceva rimbalzare i palloni, come li teneva in mano, come spalmava il grasso sul cuoio. Ci metteva il cuore. Sa cosa le dico? Dico che ha ragione lui perché il pallone ha un’anima.» Davanti al portone di casa, Napo non avrebbe smesso di parlare fino a notte fonda, ma Nonno Garella, allungando un braccio sulla sua spalla, lo aveva congedato con una lapidaria sentenza. «Bisogna conoscere queste cose per amare il calcio. Buona notte, ragazzo mio.»
Palla al centro. I pochi tifosi rimasti erano pronti a imbavagliare opportunamente il Nando Martellini, il quale comunque durante l’intervallo non aveva perso tempo con le sciure del catechismo che, scansando le sue lusinghe, lo avevano cooptato per sbrigare le ultime faccende. Vista la malaparata sui due fronti il telecronista aveva abbandonato il microfono e si era eclissato verso il bar della piazzetta per scroccare l’ultimo prosecco prima di rincasare dalla signora Pina, una delle più accese perpetue di tutta la parrocchia.
Le squadre erano schierate. Il Banana era pronto per il calcio d’inizio. Vicino a lui Napo con il pallone ancora tra le mani. Per un istante l’odore del cuoio gli balzò dentro le narici risvegliando in qualche angolo della memoria i gesti di passione del Cioppi. Dopo aver ripulito la palla per bene con la manica della maglia, la sollevò come per fissarla negli occhi e da uno stadio superiore della sua umana percezione spuntò il volto della Vale. Con un movimento rubato al subconscio Napo posò le sue labbra sul cuoio. Poi fece sgusciare la palla sul petto per strappare ancora qualche attimo alla fantasia di un abbraccio. Ancora stretta tra le sue mani la posò con una carezza nel centro del dischetto. In quei gesti c’era tutta la tenerezza di un ragazzo che sogna la sua prima uscita con una ragazza. E l’impaccio e il subbuglio che rimbombavano dentro si erano stampati su un mezzo sorriso un po’ ebete. Prima di darsi contegno e guardare in faccia gli avversari roteò gli occhi con circospezione e un pochino di imbarazzo intorno al campo, per notare se qualcuno tra il pubblico avesse scoperto il suo segreto, la sua intimità con la palla. Solo alla fine di una panoramica circolare, si voltò come uno scolaro con le guance rosse verso la panchina dove stavano le ragazze.
«Siiii, c’è!» Un minuto prima che don Antonio desse inizio di nuovo alle ostilità, un sussulto nascosto nel suo capriccio gli scappò fuori dalla bocca. «Oh Napo, tutto bene?» lo scosse il Banana con un filo di ansia nella voce. «È ancora lì!» articolò il capitano con un soffio concitato. «Ma tu sei fuori,» abbozzò il Banana con quel mezzo sorriso di complicità che solo lui poteva permettersi. «È lì ti dico, la vedi?» replicò il riccioluto aggrappandosi al braccio del biondino. «Ma chi?» Per spezzare definitivamente l’interrogativo del Banana, Napo gli prese le mascelle tra le mani e le puntò contro quella selva di capelli neri che sventolavano come una bandiera dietro la panchina. In cambio ci guadagnò un’amichevole gomitata sulla bocca dello stomaco, quel tanto che basta per far risalire i succhi gastrici innaffiati con il tè. «Ma sei scemo?» protestò Napo con la voce strozzata. «Non fare il furbo con me. Lascia stare per un momento la Vale. Adesso, dobbiamo vincere una partita.»
Il barbetta e il suo amico butterato erano ancora lì davanti più spocchiosi di prima, ma Napo aveva tutte le intenzioni di togliersi lo sfizio di vedere nei loro occhi la sconfitta. Sollevata la sottana, il reverendo arbitro fece uscire dal fischietto un tuono che riaccese fulmini agonistici sopiti. L’azione rapidissima: tocco corto al Banana che scodella la palla sopra la testa della prima linea di centrocampo a incrociare lo scatto fulmineo di Mezzo Litro. Slalom tra due birilli e sgroppata fino alla linea di fondo: traversone al centro, mischia pazzesca in area e incornata di Pezzey nel sette. Raramente si possono vedere simili prodezze nel campetto di un oratorio. Anche il vecchio parroco non ricordava a memoria un’azione così corale e un gol così folgorante.
L’ammucchiata di carne che si srotolò fin quasi ai piedi delle panchine dietro la porta era un sacrificio alle divinità del pallone. Tutta la squadra aveva sepolto Pezzey sotto chili di gioia, persino Garella aveva abbandonato i pali per gettarsi sopra quella piramide umana di sette piani che rischiava di togliere il respiro allo sfortunato autore del gol di vantaggio. Tra braccia, gambe e magliette sporche anche Napo cercò un varco per riprendere fiato e trovare la luce. E la fetta di cielo bianco che aveva appena conquistato si riempì del sorriso felice della Vale come un arcobaleno, ma solo per un istante. Il Banana gli aveva già afferrato la testa per ricacciarla dentro quel totem del piacere. Non aveva ancora finito di assaporare il sudore dei suoi compagni di squadra. Anche qui serpeggiava l’eterna esitazione davanti a un bivio.
La reazione della Ghisolfa fu veemente. La difesa aveva alzato il suo baricentro, sospinta dall’incitamento del loro allenatore che si sbracciava peggio di Carletto Mazzone. Si buttavano su ogni palla come uno sciame di api sul miele, infrangendo le più basilari regole estetiche del calcio. Il barbetta e il butterato picchiavano come fabbri e un paio di volte si erano presentati minacciosi davanti a Garella che, magicamente, aveva neutralizzato due tiri angolati e velenosi con una presa plastica. La partita cominciava a essere divertente, tra i continui rovesciamenti di fronte che mettevano le ali alle scarpette di quelli della Ghisolfa.
L’assedio durò un’eternità. Il barbetta suonava la carica dell’assalto finale e tutta la Ghisolfa gli cammellava dietro. Schiacciati dentro l’area, Napo e i suoi compagni avevano costruito un muro invalicabile a difesa della porta ancora inviolata. Bisognava proteggere il risicato vantaggio. Da ogni dove piovevano pallonate contro lo specchio della porta sigillata da un magistrale Garella che riusciva a stupire persino se stesso. E quando il portiere non ci arrivava era la saracinesca di Pezzey e della Lecca a rimbalzare gli assalti a testa bassa della Ghisolfa. Nonno Garella era una sfinge. Piantato sul bordo del campo, in maniche di camicia, non riusciva a muovere neppure il sopracciglio. Anche don Antonio, a dispetto del suo fisico che gli conferiva l’aspetto di un triatleta, attaccava a grondare dentro la sua tonaca nera, nonostante un vento polare. La sua mascella da divo seriale era imperlata di sudore e la tutta la sua muscolarità declinava minuto dopo minuto nel fascino di un paracarro.
«Toglimi dalle palle ’sto qui,» gridò Garella a Pezzey, che stava sistemando la barriera davanti alla porta. I quattro minuti di recupero concessi dal reverendo arbitro con estrema generosità si condensarono nell’ultima occasione della Ghisolfa per agguantare il pareggio: un calcio di punizione al limite dell’area, fischiato con zelante precipitazione dal don. Il pilastro centrale della difesa fece valere la sua stazza e senza tanti complimenti sollevò di peso l’avversario che ronzava intorno al portiere. «Quattro in barriera,» ordinò deciso, mentre il don cercava di far rispettare la distanza regolamentare alla difesa. Il barbetta e il butterato erano sulla palla e confabulavano a bassa voce per nascondere lo schema che avevano in mente. Il Banana si piantò sul palo di destra per coprire il lato corto della barriera; Garella saltellava dall’altra parte della porta con gli occhi spiritati sulla sfera. Napo, primo uomo in barriera, lavorava di gomito per mantenere la posizione insidiata da un avversario che spingeva come un treno per creare una breccia nel muro difensivo.
Il sole pallido che colava a picco sul campetto non poteva competere con il calore che gli ultimi spettatori superstiti riuscivano a infondere alla squadra nel momento decisivo della gara. Nel frastuono di schiamazzi e di fischi, Napo aveva fermato l’immagine su Nonno Garella immobile a bordo campo, scamiciato e con il berretto di lana tra i denti. Dietro di lui, in una massa indistinta di gente, aveva riconosciuto un profilo assai familiare che gli fece strabuzzare gli occhi, come una pallonata sullo stomaco. Si era passato la manica della maglietta sugli occhi per asciugare il sudore ma anche per mettere a fuoco quella figura, apparsa all’improvviso come un miraggio. Cercò prima lo sguardo di Mille Lire che lo teneva a braccetto per serrare le maglie della barriera. Ma quello era già in catalessi, non tanto per la tensione agonistica, ma più per la fifa di prendersi una pallonata in faccia. Provò a voltarsi un istante per aggrapparsi alle chiome nere della Vale, ma non fece in tempo a inquadrarla in quel subbuglio di eventi. Neppure don Antonio poté essergli di conforto, tutto preso com’era dalla spocchia di sommo giudice del destino della gara. Tornò a guardare da quella parte e, ancora una volta, vide solo quella coppola che gli metteva una certa ansia addosso.
La fragilità dell’essere umano si rivela davanti a un’emozione. Che si frantuma in mille pezzi di cristallo e ognuno riflette una luce e un colore diverso. Napo si sentì inghiottire in un caleidoscopio di piacere e di paura. I due ceffi della Ghisolfa iniziarono a poco a poco ad annebbiarsi, il pubblico a bordo campo prese a dondolare liquido e anche tutto il campetto sembrava cullarsi dentro gli occhi di Napo, sospesi nella bolla di una lacrima. Paltò grigio, coppola in testa, braccia conserte e bocca cucita. Che ci faceva lì? Proprio adesso? Finora non si era mai preso la briga di degnarlo di uno sguardo, magari di un rimprovero. E adesso si nascondeva dietro il mister come se dovesse espiare una colpa.
Le ostilità sono le prime a prevalere, ma durano poco dentro un ragazzino nel guado dell’adolescenza. Poi emergono l’eccitazione e l’apprensione, insieme. La forza di un vulcano in una mano che si stringe nell’indeterminatezza di uno spavento nell’altra. Quindi, qualcosa che assomiglia alla felicità copre tutto. E lì, maligno, spunta l’orgoglio. Alla fine, l’aveva vinta lui. Era stata dura, ma l’aveva vinta lui. Aveva atteso mezzo campionato per godersi quell’istante. Per dimostrare che aveva talento. Per invocare un briciolo di attenzione. La bolla liquida aveva ormai circondato la pupilla ed era pronta a sgorgare sulle guance senza vergogna. Solo in quel momento Napo ebbe il coraggio di sollevare di nuovo gli occhi sopra le spalle di Nonno Garella per sincerarsi che sotto quella coppola ci fosse davvero suo padre.
(continua)
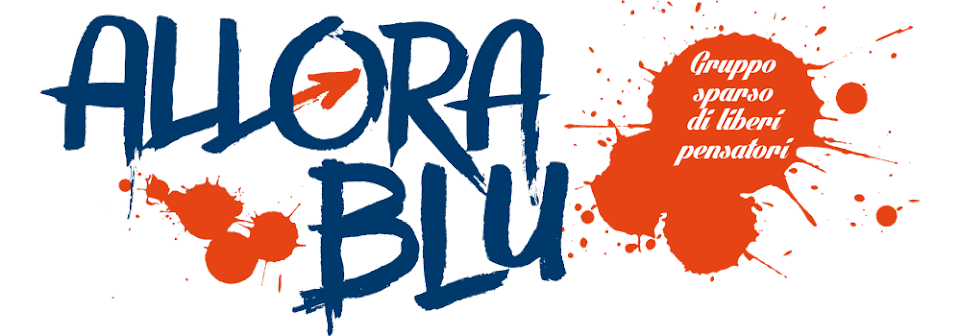
Nessun commento:
Posta un commento