(prima parte)
Il signor arbitro
Il baretto del Villapizzone stava ormai chiudendo. Luigino, appisolato sul bancone tra una coppa d’ottone e la zuccheriera, smerciava le ultime birrette ai tiratardi dell’ultima partita del venerdì che, dopo la doccia, cercavano ristoro prima di disperdersi nella notte. Seduti intorno ai tavolini, i ragazzi della Visconti polemizzavano con l’arbitro sui momenti salienti della gara: «Signor arbitro, ma perché ha fischiato la mia entrata in scivolata sul numero sette: io ho preso la palla, pulito, e quello non l’ho neanche sfiorato,» attaccò il Bicio, mentre trangugiava la sua birra seduto sul tavolino.
«Mio caro ragazzo, non si può entrare da dietro, lo sai. Tutti avrebbero fischiato,» ribatté affabile il giudice di gara, che non disdegnava attardarsi con i ragazzi per fare quattro chiacchiere e scroccare l’ultimo bicchiere della staffa.
«Sì, vabbè... Ma l’ha vista che sceneggiata: manco gli avessi spaccato le gambe! Io avrei fischiato la simulazione,» insistette acido il Bicio.
«Eccheccazzo! Hai fatto uno zompo di quattro metri prima di acchiappare il pallone e meno male che non l’hai preso a quello, sennò dovevamo chiamare la Croce Verde.»
«Ecco, vede? Lo dice anche lei che non l’ho nemmeno toccato. Sono entrato dritto sulla palla e mi sono pure sgarbellato la coscia. Cazzo, mi brucia ancora!» teneva duro il Bicio, sottolineando il gesto atletico che evidentemente gli era rimasto impresso nella mente. I compagni di squadra che erano rimasti nel baretto cominciavano a spassarsela.
«Eh, giovane... facciamo così allora: la prossima volta che ci riprovi ti becchi pure il cartellino rosso sotto al muso. Così, non ci scassi più la minchia. Vabbuò!» Risata collettiva.
«Scusi signor arbitro, ma com’è che lei... lei fa... l’arbitro?» lo pizzicò di sottecchi Vitellozzo un po’ per troncare quella noiosa polemica da
Domenica Sportiva, un po’ per genuina curiosità.
«Non mi fraintenda, per carità. Ma perché una persona adulta come lei tutti i venerdì, con il freddo che fa, si mette in macchina, arriva fino a qui e si mette ad arbitrare ventidue sfigati che corrono dietro a un pallone? Chi glielo fa fare?»
Nel baretto calò un gelo pesante di attesa. I trofei che segnavano la polverosa gloria del Villapizzone tornarono a brillare per un istante. Il poster del Milan, appeso tra la bandiera viola e gialla del Villapizzone e i gagliardetti delle squadre che lì avevano giocato, sembrò scuotersi come investito da una raffica di vento. La bottiglia del Biancosarti oscillò paurosamente sulla mensola di vetro e specchio del bar. I quattro vecchietti in fondo alla stanza sospesero la partita di tressette e allungarono le orecchie. Anche il Luigino smise di strofinare bicchieri e alzò lo sguardo verso l’arbitro.
Era un ometto sulla cinquantina, tutto d’un pezzo. Capelli folti e neri appiccicati alla fronte, culo basso e un forte accento meridionale. Nessuno conosceva il suo nome, né da dove veniva o che cosa facesse nella vita. Probabilmente, non fotteva niente a nessuno. Un omino insignificante che non ha un cazzo di meglio da fare la sera. Uno che aveva imparato le regole del calcio sugli almanacchi a fumetti e sventolava il suo tesserino federale come uno sbirro a un posto di blocco. Per tutti, però, era il “Signor arbitro”. Per quelli della Visconti, che al Villapizzone giocavano in casa, era qualcosa di più. Con loro, tra un rigore e una pacca sulla schiena, tra un cartellino e una stretta di mano, tra una bestemmia e un bianchino, giocava a fare il buon padre di famiglia rivelando ogni qual volta insospettabili pennellate d’umanità.
I vetri appannati delle finestre affacciate sul campetto ormai buio e deserto lasciarono filtrare lo sferragliare dell’ultimo treno delle Nord che, con la sua carica di suggestione, saturò l’aria del baretto. Gli occhietti neri dell’arbitro cercavano di aggrapparsi alla bandiera viola e gialla sulla parete per strappare le ragioni nascoste dietro una casacca nera. O forse per azzeccare una balla che avrebbe messo a tacere una curiosità, tutto sommato, innocente. Prima mise a fuoco Vitellozzo con occhi torvi, poi si alzò dalla sedia con il bicchiere di bianchino in mano come un attore a fine carriera. Ostentando una certa esperienza, si portò il bicchiere alla bocca e lo scolò d’un fiato. Quindi, eloquente e sincero, con un sorriso sbieco scrollò le spalle in segno di resa.
Come un branco di iene, i ragazzi della Visconti avevano annusato il sangue e si accanivano sui brandelli della preda. I quattro vecchietti abbandonarono definitivamente il tressette e si avvicinarono alla carneficina trascinando le sedie rumorosamente. «Scusi, signor arbitro, ma con tutte le mignotte che ci sono sulla circonvallazione...» azzannò per primo il Conte che, quanto a classe, non glielo metteva in culo nessuno. «Magari è frocio, sempre con rispetto parlando,» attizzò in seconda battuta il Lillo invocando la risata degli amici. Il Pelanda cercava di rimettere le cose a posto, ma con scarsi risultati. «Dai ragazzi, lo sanno tutti. L’arbitro è per definizione un cornuto,» sparò alto il Chivas. «E il nostro non porta la fede al dito,» osservò acuto il Jolly. Pure Pollo provava a buttare acqua sul fuoco: «Noi non possiamo lamentarci, dove lo troviamo più un arbitro così?” Ma anche le sue parole avevano una vaga idea di presa per il culo.
L’ombra di due spalle gigantesche si allungò sul tavolo della disputa. Bottiglie di birra semivuote circondate da cinque o sei facce da sberle e un cappotto grigio che vacillava in mezzo a quel ring. «Ragazzi occhio, la state facendo fuori dal vaso.» Il Luigino cominciava a incazzarsi. Quelli della Visconti ci speravano. «Che cazzo vuole quello?» intonò Zio. Intorno al tavolo cominciava ad aleggiare quell’aria che si respira di solito prima di una rissa in campo. Il Chivas si era raccolto i capelli in una coda lunga e bionda, il Lillo aveva spostato la sedia all’indietro e afferrato il boccale di birra ormai vuoto nella mano destra, persino il vecchietto che giocava a tressette si lisciava i baffi bianchi come se dovesse pregustarsi uno scontro tra titani. Ma, puntuale, l’arbitro con un gesto plateale della mano placò i bollori del barista, sottolineando con lo sguardo rivolto ai nonnetti che aveva la situazione sotto controllo. Il Rosso, che veniva a fare il guardalinee dietro lauto compenso (paga doppia sotto la pioggia), provò a imboccare un’altra pista forse ancora più scivolosa. «No, perché lo sa anche lei. Questa è una zona malfamata. Quelli di via Bianchi menano i tranvieri al capolinea. Qua fuori nel parcheggio quando va bene ti bucano le gomme, sennò ti zanzano direttamente la macchina. Gira droga... Lei non ha paura?» Ormai i quattro vecchietti erano entrati dentro la scena e quello con i baffi bianchi e i capelli tirati indietro, scarnificando la Marlboro nel posacenere, apostrofò il Rosso con un ”Ma che minchia vai dicendo!”.
«Venite con me, devo farvi vedere una cosa.» Adesso parlava sottovoce l’arbitro e dopo tutta quella sarabanda di velenose insolenze era ancora in piedi, non mollava. Anzi, era sempre pronto a contrattaccare a muso duro, tra bestemmie universali e insulti in dialetto barese. E qualche volta ci capitava il colpo basso. Raccolti i borsoni, in fila indiana la squadra dribblò i tavolini e si mise nella scia dell’arbitro che, salutato il Luigino e chinato il capo verso i quattro vecchietti, guadagnò l’uscita. La luce dei lampioni non arrivava a illuminare il parcheggio di ghiaia e fango del campetto da calcio, protetto dalle ombre dei casermoni di via Bianchi. Nel buio l’arbitro si muoveva come se fosse in un film neorealista. I riflessi delle pozzanghere lo facevano ancor più piccolo di quello che era. E la sua sagoma nera si allungava sul vialetto del parcheggio tra il fruscio degli olmi.
Dopo qualche passo, di scatto, si fermò davanti a una 127, che al buio pareva color amaranto. «Bella macchina,» disse con un tono di voce che anche l’ultimo della fila avrebbe dovuto sentire. Gli girò intorno, sfiorando cofano e fanali con le mani infilate nei guanti di lana. Si fermò davanti alla portiera del passeggero e, frugandosi le tasche, sollevò gli occhi per passare in rassegna il suo pubblico. Vista da lontano la scena poteva tranquillamente finire nelle colonne di cronaca del Corriere insieme con una foto in bianco e nero, dove si vedevano cinque balordi che circondavano minacciosamente un vecchietto.
Con una calma disarmante l’arbitro aprì la portiera e l’abitacolo s’illuminò di una luce fioca riflessa sul rosario che pendeva dallo specchietto retrovisore. Sul cruscotto le foto di Padre Pio e Papa Giovanni mandavano benedizioni. Appoggiò la mano sinistra sul sedile e, chinandosi malfermo, aprì il vano porta oggetti. Tirò fuori un aggeggio avvolto in un panno nero. Si alzò e si mise al centro del cerchio che si era formato intorno a lui. Buttò gli occhi sul Rosso per raccogliere con lui lo sguardo di tutti gli altri. Lentamente cominciò a sfogliare il panno e sotto la luce storta dei lampioni dalle sue mani spuntò una Beretta, che nessuno dei ragazzi aveva mai osservato così da vicino nella propria vita. «Hai visto? Il cannone io me lo porto sempre appresso. Perché a me nessuno deve scassarmi la minchia.»
***
Il fischio d’inizio di una partita di calcio ha un recettore potentissimo nel cervelletto, che mette in circolo insospettabili ormoni in tutto il corpo, a prescindere dall’età. Succede a San Siro come nei campetti spelati della periferia. È come un lampo di luce che s’infuoca negli occhi, un brivido muscolare che percuote i neuroni, l’istante che accende una spettacolare tempesta agonistica. Non esiste il caldo. Non esiste il freddo. Non esiste perdere.
Qualcuno si faceva il segno della croce, come un goffo geroglifico tra la fronte, il cuore e le spalle. I più raffinati si chinavamo persino a baciare il terreno con la mano, sotto lo sguardo appagato del reverendo arbitro. Gli avversari erano lì, schierati in mezzo al campo come una falange macedone pronta a dardeggiare pallonate contro la porta di Garella. Venivano dall’altra parte del Ponte della Ghisolfa, quella più vicina al Centro e, quindi, già più aristocratica. Erano piuttosto grossi per la loro età, il più alto ostentava una fitta peluria nera intorno al mento, quello al suo fianco aveva una faccia spigolosa devastata dall’acne: incutevano una certa idea di soggezione. Però il sole pallido di gennaio e tutte quelle voci che gridavano i loro nomi potevano spezzare il vapore di freddo che usciva dalla bocca di Napo e dei suoi amici come un anelito di paura.
Il primo tiro in porta della Ghisolfa finì dritto tra i rami più alti dei platani annoiati dietro la porta e, nella mobilitazione generale del pubblico, ci vollero dieci minuti buoni per recuperare la palla. “Quei bravi ragazzacci” ne approfittarono per andare a maramaldeggiare con gli amici o con le ragazze, ma anche per espellere i fantasmi della paura. «Rinvio di Garella,» richiamò all’ordine il Nando Martellini. E già dai primi fraseggi di gioco si poteva afferrare l’impalpabile consistenza degli ospiti.
Sugli spalti e sulle tribune cominciavano a riecheggiare arie wagneriane, quelle che profumano come di vittoria. Ed era sempre Napo a suonare la carica. Smistava palloni come il capitano Willard smazzava le carte tra i cadaveri dei vietcong. Scartava gli avversari come un surfista sul Mekong. In quella giungla di capelli che aveva in testa, gli occhi sbucavano anche sulla nuca e, con le palpebre socchiuse, poteva suggerire la traiettoria di un gol con l’invenzione di un colpo di tacco. Uno così può far paura persino al colonnello Kurtz.
Era stato il contatto duro contro il butterato a far ripiombare Napo nella realtà di una zolla di terra gelida che, sul ciglio dall’area di rigore, vibrava sotto il suo corpo rannicchiato intorno al dolore. All’ennesimo affondo si trovò disteso con la faccia nella terra e nel gesso e con una caviglia a brandelli. Mentre i muscoli della faccia si contraevano in uno spasimo di sofferenza, montava in lui la consapevolezza di una superiorità non solo tattica: dovevano stenderlo per fermarlo. Pochi secondi per riaprire gli occhi e scoprire che da quella posizione si ha una dimensione diversa del campo di gioco, senza forma e senza colori. Non c’erano più le case rosse che si affacciavano sull’oratorio, non c’erano più le sottane colorate dietro la porta. Persino la tonaca nera del don era scomparsa. Solo terra, sassi e scarpe. Magliette sudate e, in lontananza, sagome bercianti che, sottosopra, facevano più paura degli avversari. Persino il campanile aveva preso un aspetto più minaccioso e sembrava sul punto di cadere e conficcarsi in mezzo al campo come un castigo biblico.
La baraonda di voci, insulti e fischi, che faceva da colonna sonora alla dolorosa commedia di Napo, si ammutolì per un istante al perentorio fischio di don Antonio che caracollando dentro l’abito talare indicava solenne il dischetto di rigore. Poi un boato che, rimbombando contro i muri grigi della chiesa, aveva scosso i platani dal loro torpore invernale e spostato gli occhi e l’attenzione di tutto lo “stadio” sull’arbitro, lasciando Napo solo a contorcersi nel suo male. Il reverendo arbitro troneggiava in altezza e possanza sul mucchio selvaggio della Ghisolfa che però non si dava per vinto e lo serrava da tutti i lati, tra plateali proteste e professioni d’innocenza. Il don ci mise non pochi minuti per passare dal sorriso risoluto a occhi torvi che minacciavano punizioni poco celestiali.
C’è un’antica consuetudine nel gioco del calcio che non viene mai abbastanza osservata: chi subisce il fallo, non calcia il rigore. L’antologia del pallone è piena zeppa di episodi e aneddoti sulla massima punizione. Anche tutto quello che si legge in proposito sui giornali o si vede alla televisione è vero, anche se pochi sanno raccontarlo e ancora meno sono quelli che sanno guardarlo. Il calcio di rigore non si può imprigionare dentro una parola o rinchiudere in un fermo immagine. È uno stato d’animo in bilico tra l’angoscia dell’errore e il brivido dell’esultanza. Il dubbio s’insinua sulla faccia del portiere e risale con un fremito sulle cosce del rigorista in un turbine di sensazioni che sfumano dalla superbia alla desolazione, dall’ansia al riscatto, dalla gloria alla disgrazia. L’eterna esitazione davanti a un bivio: destra o sinistra.
Sul dischetto, intanto, il conciliabolo tra i compagni di squadra, come al solito, non portò a un verdetto unanime; anzi, fece alzare la temperatura tra il Banana e Napo che si strappavano la palla di mano sotto gli sguardi nervosi degli spettatori. Ognuno dei due aveva un valido curriculum per presentarsi solo davanti al portiere, ma quello di Napo vantava una tacchettata in più, appena conquistata sul campo.
«Rigore, calcio di rigore!» Il Nando Martellini irruppe con categorico tempismo nelle orecchie degli spettatori che cominciavano a manifestare i primi sintomi d’insofferenza verso quel fastidioso ronzio che accompagnava inopportuno le evoluzioni sul campo. «Ancora una manciata di minuti alla fine della prima frazione di gioco: il momento è decisivo. Forza ragazzi! Dopo un lungo conciliabolo pare che calcerà Napo. Eccolo che afferra la sfera, la posiziona al centro del dischetto.» Una pausa per sottolineare l’ineluttabilità del momento. «Tutto pronto: uno sguardo al portiere, un cenno d’intesa all’arbitro che fischia...» Un silenzio totale. «La concentrazione di Napo... Ecco la rincorsa... Tiro...»
Il boato dei tifosi soverchiò la puntigliosa telecronaca che, peraltro, rimase strozzata nella gola del Nando Martellini. Le facce dei tifosi s’incupirono, insieme con le urla soffocate che piovevano dagli spalti: un singulto simile al fiotto d’aria che esce dalla bocca dopo un cazzotto nello stomaco. Era quello, più o meno, lo stato d’animo di Napo, rimasto lì a guardare il palo, appena rasato dalla sua fiondata, come un bambino osserva il cielo buio. Sono momenti drammatici: gli occhi fissano un punto astratto oltre la porta, le gambe sono di piombo, il tronco si piega in avanti e le braccia cercano sostegno sulle ginocchia.
Il portiere, spiazzato senza neanche lo sforzo di una finta, non venne degnato neppure di un’occhiata di pietà da Napo, ma il brufoloso e il barbetta e tutti gli altri avversari già lo celebravano come fosse Albertosi. Lui se ne stava lì, inginocchiato davanti alla porta come un miracolato. Napo sputò per terra, quasi per scacciare l’amaro sapore della delusione che aveva riempito la sua bocca. Con le mani incollate alle ginocchia, alzò gli occhi per tornare sulla beffarda traiettoria del tiro. L’abbraccio caldo del Banana lo colse inchinato davanti alla rete ancora vergine, quasi stesse espiando un peccato inconfessabile.
«Bel culo, vero? Si chiama Vale. Se vuoi, te la presento.» Le parole del Banana affilate e striscianti entrarono nelle orecchie di Napo come un’iniezione di adrenalina. Con un movimento quasi innaturale Napo attorcigliò la testa intorno al collo per guardarlo in faccia. Per la seconda volta, nel giro di pochi minuti, si ritrovò a scrutare il mondo sottosopra, ma questa volta il dolore aveva lasciato il posto a un sottile, inatteso piacere. Visto dal basso il Banana era un’ombra nera che si stagliava come una quercia contro il cielo bianco. Immenso e potente, sembrava un faro capace di leggere l’orizzonte un po’ più in là. Più da vicino, aveva un ghigno complice che si apriva nello scintillio dei suoi occhi ammiccanti, come se avesse anticipato le fantasie di Napo con un assist preciso. Il frastuono di fischi che precipitava dagli spalti si dissolse ben presto come un rintocco di campana in lontananza. Un diluvio di male parole e facce incazzate si cristallizzava come un murales sullo sfondo della chiesa. Avvolti in una nuvola di complicità, Napo e il Banana tornavano verso centrocampo. Camminavano piano, con la dignità di chi si porta sulle spalle una grave responsabilità e gli occhi di sfida puntati sul pubblico inferocito. Tutti a guardare il dito. Pochi eletti hanno il privilegio di vedere la luna. «Già, bel culo.»
Valentina era una tipa timida che non spiccava certo per eccentricità tra l’assortito campionario femminile dell’oratorio. Benché fosse totalmente avulsa da qualsiasi logica del pallone, non si era persa una sola partita della squadra della parrocchia. Vero è che la domenica mattina, dopo la Messa, l’unica attrazione degna di nota erano quelle braghe corte che rimbalzavano da una parte all’altra del campetto di calcio. Materia che, peraltro, riempiva di chiacchiere e sospiri le panchine dietro la porta degli avversari, eletto punto di osservazione strategico dalle ragazze dell’oratorio. Insieme con le amiche, accompagnava ogni affondo della squadra di casa con gridolini sospesi a mezz’aria, ma quando la palla finiva tra le scarpette di cuoio di Napo la sua mano nascondeva la bocca e la voce le si spezzava in un brivido clandestino. Nonostante il disappunto delle sue amiche che si scioglievano solo davanti al ciuffo biondo e ribelle del Banana, Vale aveva occhi solo per lui. Lui, con quella chioma di riccioli scapigliati, riempiva il campo invocato dai compagni e osannato dai tifosi; lui, refrattario all’inchino, dominava il gioco come un direttore d’orchestra indifferente ai fischi o agli applausi; lui, che non si era mai spinto oltre la linea di fondo campo nemmeno per soddisfare le sue più astratte fantasie adolescenziali. Almeno fino a quel momento, fino a quando una palla velenosa, fuggendo al suo destino, aveva accarezzato le gambe lunghe di quella gattina tremolante.
«Riprendono le operazioni di gioco,» annotò con fare da notaio il Nando Martellini. «La Ghisolfa prova adesso a ripartire con lunghi fraseggi nella zona mediana del campo, che vengono fermati in questo istante dal duplice fischio del reverendissimo arbitro. Fine primo tempo.» Una breve pausa. «Gentili telespettatori, che partita! C’è da segnalare subito una grandissima occasione sprecata pochi minuti fa, con il rigore fallito da...»
La voce di Nando Martellini andava in dissolvenza sommersa dai commenti a caldo dei tifosi, mentre la squadra guadagnava lo spogliatoio tra due ali di pubblico che ora li incoraggiava, ora li scherniva. Don Antonio si era intrattenuto con un gruppetto di ragazzi e nonni a bordo campo che discettavano sugli schemi di gioco della squadra in uno zibaldone di dialetti che abbracciavano Palermo e Milano, assecondando con ampi gesti della testa l’analisi tecnica del primo tempo. Gli ultimi a varcare la soglia che conduceva allo spogliatoio furono il Banana e Napo. Prima di scomparire nella pancia della chiesa, per un attimo, Napo voltò lo sguardo un’ultima volta verso la porta che gli aveva negato l’esultanza del gol e, fatalmente, incrociò gli occhi smarriti della Vale.
Il gioco del calcio si accompagna a rituali che si perpetuano partita dopo partita e, alla lunga, s’incidono nella memoria con un marchio a fuoco. E il tè bollente tra il primo e secondo tempo è forse la liturgia più solenne tra chi ha frequentato i peggiori campetti della periferia. Il suo profumo aveva invaso lo spogliatoio dell’oratorio, mescolandosi alla puzza di piedi e di sudore che ristagnava sui muri e sotto le panchine di ferro e legno. A turno, tutte le mamme dei giocatori avevano il compito di riempire il termos da cinque litri con la preziosa pozione. La madre della Lecca era la migliore, preparava un tè denso e zuccherato che, oltre ad assicurare un posto fisso in squadra al figlio scarpone, aveva proprietà taumaturgiche. Prima ancora di riscaldare lo stomaco stemperava i bollori agonistici e i muscoli si lasciavano sedurre dal suo aroma scivolando in uno stato di vigile torpore.
Appiccicati allo schienale della panchina, le gambe divaricate sul pavimento umido e, tra le cosce sudate, il bicchiere di tè in mano parevano gli ultimi reduci della brigata Garibaldi, raccontava il nonno del Garella che era stato partigiano in val d’Ossola e adesso tentava di insegnare ai ragazzi dell’oratorio il valore della lealtà sotto forma di un pallone. Il rigore sbagliato da Napo venne subito bollato come “una parentesi sfortunata”, azzardò con garbo inopportuno Mezzo Litro aprendo i microfoni dello spogliatoio. «Sì, una vera sfiga,» puntualizzò Pezzey, mentre Garella, con solide argomentazioni tecniche, stava vivisezionando ”quello scarso del portiere”. La Lecca gliel’aveva giurata al butterato: «Adesso glieli faccio assaggiare io,» grugnì mentre cominciava a limare i tacchetti delle sue scarpe. Ognuno sgranava la sua giaculatoria, forse per giustificare una prestazione piuttosto incolore come avevano certificato senza tanti complimenti i fischi dei tifosi. Solo Napo e il Banana (per solidarietà) non schiodavano gli occhi dal muro azzurrognolo, sospesi in riflessioni ben più profonde, quasi esistenziali.
«In fondo, a me, che mi frega. Ok, ho sbagliato un rigore, può capitare; ma non ho giocato male. Ho preso una traversa che è ancora lì che trema, ho messo due volte quello scemo di Mezzo Litro solo davanti al portiere e lui ha sbagliato, ho recuperato almeno una dozzina di palloni in difesa. Ma, cazzo, come si fa a sbagliare un rigore! Questi poi sono davvero scarsi. Non hanno fatto un tiro in porta...» ripassava nella mente di Napo il film della partita. Fotogramma per fotogramma selezionava le azioni migliori in campo e scartava le immagini fuori campo.
Solo due episodi non s’incastravano: il rigore sbagliato e il calcio d’angolo stampato sulla traversa. Aveva tirato un corner bellissimo calciato con l’interno del destro carico d’effetto per dargli la traiettoria a rientrare. Il portiere neanche ci aveva provato a prendere la palla e le urla dei tifosi già l’avevano battezzata in gol, ma il suono cupo del cuoio sul legno spense la luce, per un attimo. Quando riaprì gli occhi Napo vide di fronte a sé un’immagine annebbiata, fuori fuoco che a poco a poco si materializzò intorno al profumo della Vale. Fragranze provenzali che si sentiva ancora addosso al corpo, incollate sulla maglietta.
«Forza ragazzi, dobbiamo solo crederci un po’ di più,» li incoraggiò Nonno Garella, con la sua faccia scavata nella pietra e la voce potente come un comandante di brigata. «Mille Lire, devi stare più largo sulla fascia per aprire gli spazi alle incursioni di Mezzo Litro, che a quest’ora della mattina farebbe meglio a svegliarsi. La difesa regge bene, ma deve salire un po’ di più a centrocampo: questi il contropiede neanche sanno cos’è. Sui calci d’angolo, Pezzey e Mille Lire buttatevi in mezzo all’aria e fate valere la vostra altezza. Tu, Lecca, con quei piedi è meglio se rimani a coprire la difesa,» disse alzando la mano deciso per sedare sul nascere il vagito di una risata. «Napo tranquillo, qui giochiamo a pallone e, grazie a Dio, siamo ancora liberi di sbagliare un calcio di rigore. Allora, adesso proviamo così...»
Mentre passava in rassegna tutti i suoi giocatori, snocciolava tattiche e consigli che venivano accompagnati da un incessante gesticolio delle mani e della testa. Nello spogliatoio regnava un silenzio irreale, Nonno Garella li fissava a uno a uno e loro lo ascoltavano con devota attenzione e sommessi sbadigli. Con gli occhi ormai a mezz’asta, Mezzo Litro era sprofondato in uno stato di contemplazione assai vicino al coma. Pezzey e Garella presero a giochicchiare con il pallone sotto la suola delle scarpette e disegnavano geometrie astratte sulla pellicola di umido che si era formata sul linoleum del pavimento. La Lecca si preparava a far paura: arrotolò i calzettoni alle caviglie, mettendo in bella mostra i parastinchi che sporgevano come una corazza dai polpacci nudi. Mille Lire ne approfittò per andare a pisciare, ma sciaguratamente inciampò tra i piedi del Banana e stramazzò al suolo tra le gambe di Nonno Garella. Che scoppiò in una fragorosa risata. Qualsiasi tattica avesse avuto in mente il valoroso allenatore per ribaltare le sorti della gara, sarebbe stata sicuramente meno efficace dell’assordante boato che si levò dallo spogliatoio per accompagnare il volo di Mille Lire. Anche Napo alla fine cedette e si tuffò nella bolgia che si era venuta a creare nel bunker, senza però riuscire a scacciare quel tarlo che cominciava a roderlo dentro.
La squadra tornò in campo inspiegabilmente baldanzosa come se avesse già vinto la partita e il pubblico s’interrogava esterrefatto sulle doti di spogliatoio di Nonno Garella che, come da tradizione, chiudeva la fila che menava in campo con un ghigno che gli tagliava la faccia da parte a parte. Napo passò con una rapida occhiata la coreografia di pubblico che aveva deciso di sprecare un’altra mezz’ora (più recupero) della propria vita per assistere a quella brutta partita di calcio.
Sopra una selva di teste e di coppole senza volto e senza colore, s’impigliò tra i capelli neri della Vale che volavano nel vento, magari, per catturare il suo sguardo. Era ancora lì, avvolta nel suo cappotto noisette, e riempiva lo spazio con l’eleganza di un tulipano e l’allegria di un girasole. Fragile come un giglio si teneva stretta nelle spalle e saltellava sulla punta dei piedi per esultare e per riscaldarsi insieme con le amiche. Il rientro in campo della squadra fu un fremito che attraversava la schiena delle ragazze eccitate, si propagava da una mano all’altra e s’ingrandiva di bocca in bocca, fino a sciogliersi in stridule grida che sembravano un innocente orgasmo.
(continua)
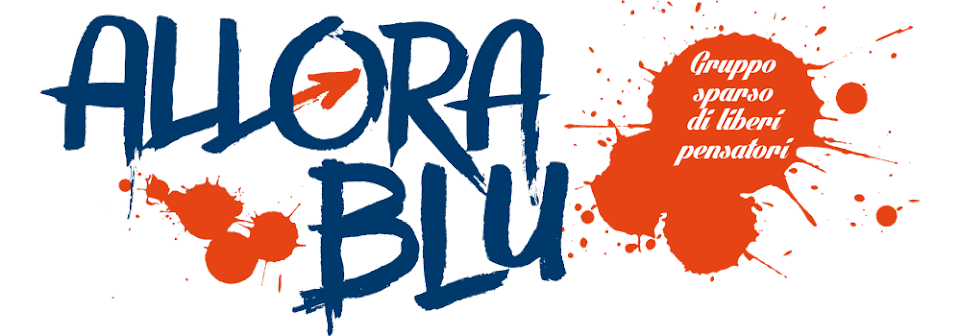
Nessun commento:
Posta un commento