Anche Gigi Riva sbaglia i rigori
Giovanni Francavilla
Alle mie piccole, grandi donne
Domenica mattina, alle nove meno un quarto, il suono delle campane che annunciavano la Santa Messa arrivava sempre in ritardo a casa di Napo. Lui lo aspettava sdraiato sul letto già vestito, sotto il poster di Cruyff, a sfogliare il suo album delle figurine Panini. Il primo rintocco, intenso e grasso, lo faceva scattare in piedi e correre verso la finestra che, dopo i binari del tram protetti da immensi olmi, si affacciava sul campetto da calcio dell’oratorio. Nelle gelide mattine di gennaio pareva un fazzoletto siberiano di terra e sassi, ma il gesso che delimitava grossolanamente il perimetro del rettangolo di gioco gli dava un tocco un po’ civettuolo. Da giorni aspettava quel momento per decidere quali scarpette portare alla partita del torneo di pallone. Per la prima volta nella sua breve ma intensa carriera di pedatore, infatti, aveva due paia di scarpe da calcio: quelle nuove a sei tacchetti intercambiabili; quelle da tredici fissi un po’ più logore, ma tenute come una reliquia. Le nuove scarpette fiammanti erano il frutto di un incessante pressing sul borsellino della madre e del meticoloso pellegrinaggio tra i negozi di articoli sportivi della zona. Li conosceva tutti ormai e, alla fine, commessi e padroni tolleravano di buon grado le sue incursioni tra gli scaffali e le sue lunghe dissertazioni sulle cuciture del cuoio o sugli attacchi dei tacchetti alla suola. Poteva raccontare pregi e difetti di tutte le marche e modelli, pur non avendole mai calzate.
Non era stato facile scegliere la scarpetta che avrebbe dovuto contendersi i suoi piedi con le eterne “Pantofola d’oro” trovate, anni addietro, sul suo letto insieme con un biglietto di auguri vergato dalla madre. Alla fine, tra mille tentennamenti, si risolse per un paio di “Puma King” nere con la banda bianca: sei tacchetti d’acciaio intercambiabili, tomaia in pelle morbida, leggerissima. Maradona, per capirci, ci arrivò dopo.
Napo gettò un ultimo sguardo al cielo bianco e immobile, come una lastra di ghiaccio: giornata da tredici, pensò arricciando il naso. Ai piedi del letto, come in una baruffa goldoniana, le “Puma King”, vergini e superbe dall’alto dei loro sei tacchi d’acciaio, facevano le smorfiose con le “Pantofola d’oro”, burrose e decadenti. Nella sua infantile fantasia pareva che saltabeccassero per giocarsi un posto vicino agli aristocratici zoccoli di legno del dott. Scholl, che, di rigore, avevano un posto fisso in fondo al borsone di calcio. Alla fine si decise e, quando le scarpe ebbero piantato lì quella commedia della gelosia, Napo le sollevò delicatamente entrambe e le posò in fondo al borsone. Non poteva non sfoggiare il suo nuovo acquisto agli amici dello spogliatoio.
Il resto dell’armamentario calcistico era già pronto dalla sera prima. La divisa ufficiale era piuttosto artigianale, come quella di tutti gli altri compagni di squadra. Senza soldi, avevano deciso che maglia, pantaloncini e calzettoni fossero bianchi per le partite giocate in casa; rosso il colore scelto per le trasferte; nulla di griffato, per carità! Bastava frugare negli armadi o in fondo ai cassetti di casa per tirar fuori una maglia bianca; i calzettoni di spugna erano tra i panni da stirare e i pantaloncini si pescavano di solito nel cesto della biancheria sporca. Il risultato complessivo non era così entusiasmante dal punto di vista estetico. Messi tutti insieme i giocatori davano un’immagine scombinata, poco attenta all’uniforme, ma loro badavano alla sostanza. Accappatoio, canottiera di lana, mutande e parastinchi completavano il suo corredo calcistico. E tutto questo guardaroba, insieme all’olio di canfora, lo shampoo e il bagnoschiuma, stava piegato e ordinato dentro il suo borsone da calcio.
Una regola poco chiara della famiglia di Napo imponeva che fossero i figli i primi a presentarsi in chiesa per la funzione domenicale. È chiaro che per loro non fosse un grosso disturbo; anzi, avevano più tempo per giocare con gli amici sul sagrato e poi, senza fretta, infilarsi chiassosamente in chiesa. E, comunque, per Napo era il prezzo da pagare per giocare sul campetto dell’oratorio. Nel nome del Padre, del Figlio... la Messa era già cominciata da un pezzo, quando la madre di Napo si palesava allo scoccar del “Credo”. Suo padre a quell’ora era già al bar a giocare a carte.
Circondata da borse, borsoni e zaini, la squadretta della parrocchia si accampava nella navata di destra, non lontano dall’altare ma abbastanza vicino alla porta che conduceva all’oratorio e, quindi, allo spogliatoio di calcio. Quando il coro attaccava a cantare, accompagnato dall’organo e dalle chitarre, loro mettevano a punto schemi e tattiche per la partita, si scambiavano pareri sugli avversari che di lì a poco avrebbero guardato in faccia. O, il più delle volte, scommettevano sui risultati delle partite di serie A in un perpetuo quanto irritante bisbiglio. In altre occasioni facevano solo casino, sotto gli occhi impietriti delle perpetue sedute in prima fila con i loro foulard neri sulla testa. Finché don Antonio, sant’uomo, li fulminava con uno sguardo truce. E lì, si capisce, scattava la punizione, micidiale come una tortura cinese.
Certe domeniche la Messa non finiva mai. Capitava spessissimo, soprattutto quando il don si sentiva ispirato e in armonia con il mondo; soprattutto quando si doveva giocare una partita di cartello. I suoi modi esuberanti e il suo fisico massiccio premevano scomposti contro un abito talare troppo stretto per uno che aveva qualche anno in più rispetto a quella marmaglia imberbe che adorava solo il dio pallone. Don Antonio era il braccio destro del vecchio parroco, un omone burbero ma con gli occhi buoni e i capelli candidi che oramai aveva abdicato a favore del più giovane prete, per rispecchiarsi forse nei ricordi del suo passato.
In effetti, il novizio sapeva farsi voler bene. Poteva occuparsi di catechismo con genuino entusiasmo o fare visita a vecchiette malandate, che ricambiavano la cortesia con preghiere e manicaretti. Poteva celebrare Messa o andare al cinema, senza intaccare certi pregiudizi reazionari di taluni parrocchiani. Poteva menare le mani e assolvere peccati con la disinvoltura di un attore consumato: una via di mezzo tra don Camillo e Bud Spencer, ma molto più coreografico. E in quelle domeniche, si trasfigurava nel sommo carnefice di quel branco di brufolosi molesti alla sua sinistra che aspettava solo l’“Andate in pace”, come il fischio d’inizio della partita. Don Antonio aveva nel sangue il ritmo di un teatrante. In ogni parola metteva una carica spirituale che fermava il tempo e ogni pausa lo dilatava. Quando il brusio s’infittiva, lui abbassava impietosamente il volume della sua voce, quasi a sbucciare ogni parola che gli usciva dalla bocca con un soffio sussurrato. Operazione che metteva in seria difficoltà le perpetue della prima fila piuttosto dure d’orecchi. S’inchiodava sulle sacre scritture e centellinava con asfissiante lentezza ogni salmo, fino a implodere in una torrenziale omelia che pareva dovesse inondare, da un momento all’altro, tutta la chiesa e pure la sacrestia. Quelli che erano sopravvissuti all’infinita predica erano pronti a giurare che il don lanciasse saette dagli occhi come un dio greco, collerico e beffardo. Impossibile resistergli. Da buon prete di frontiera aveva già pizzicato i loro vizi. Del resto era inutile mentire, soprattutto quando sotto il cappotto spuntava la divisa di pallone. Si commette peccato.
Lo spogliatoio dell’oratorio era una stanza grigia con vaghe nuances azzurrognole, quasi a testimoniare la sua infelice condizione di seminterrato, a metà strada tra l’inferno e il paradiso. Dentro quel cubo spoglio, una fila di panchine di ferro e di legno stava appoggiata su quattro muri che avrebbero assai gradito una mano di pittura fresca. In mezzo a una parete c’era un poster della Nazionale del 1978, messo lì per volontà del parroco. Raffigurava la straordinaria squadra di Bearzot ai mondiali in Argentina: Zoff, Gentile, Bellugi, Scirea, Cabrini, Benetti, Tardelli, Antognoni, Causio, Rossi, Bettega. Gente che sapeva stupire i più rigorosi esegeti del pallone e, al tempo stesso, gonfiare le coronarie anche alle più placide massaie davanti al teleschermo. Sopra la porta d’accesso un crocefisso di plastica. Giubbotti e indumenti si potevano appendere ai chiodi che spuntavano dai muri come una corona di spine tutt’intorno alle pareti. In alto due bocche di lupo con vista sul marciapiede richiamavano il gelo dentro lo spogliatoio, ma lasciavano evadere gli occhi furtivi dei ragazzi a caccia di gonnelle di passaggio. Sulla destra, fuori dalla traiettoria visiva della porta d’ingresso, un pertugio apriva il passo e la vista su due orinatoi bianchi verticali, incrostati di calcare e di piscio. Una porta giallastra nascondeva pietosamente una tazza di ceramica, la sua catenella di corda e i fogli di giornale inchiodati al muro. Più in là, tre sifoni incastrati nelle piastrelle bianche arricchivano con i loro tiepidi vapori la zona doccia. Un lusso che veniva concesso a “quei bravi ragazzacci” per tutto il campionato.
Era il loro bunker, un posto epico che sudava umidità e grondava sogni. Superata la puzza di rancido che teneva lontano nasi delicati, appena dentro, sembrava di essere in un film a colori. Non come quelli che proiettavano all’oratorio, ma quelli che si vedevano al Sempione la domenica pomeriggio, nascosti dietro pesanti tendoni di velluto amaranto con le mani ben in vista. E una domenica sì, l’altra no, contro quella scenografia immobile e nuda dello spogliatoio, popolato da blatte e zanzare, sbatteva l’entusiasmo e il casino della squadra della parrocchia. Mezzi nudi, ognuno sventolava il suo idolo e tutti si accanivano a demolirlo, tra insulti e pernacchie. Osceni cori contro il Milan o la Juve si trasformavano ben presto in scandalose ingiurie ben più circostanziate, il più delle volte, all’indirizzo delle virtù di madri e sorelle. Chi aveva più fiato trascinava gli altri nell’invettiva e puntuale come la confessione a Natale lo spogliatoio si spaccava in due opposte fazioni: noi di qua, voi di là. C’era un vago sentore idealista che poteva scivolare su qualsiasi argomento: da chi doveva battere un eventuale rigore alla più figa dell’oratorio. E non se ne veniva mai a capo.
Cinque minuti al fischio d’inizio. Allacciate le stringhe intorno alle caviglie e sistemati i parastinchi dentro i calzettoni si sgusciava di corsa dallo spogliatoio, come i bersaglieri alla parata del 2 giugno. Il contrasto di luce tra dentro e fuori era abbacinante. Un’esperienza quasi allucinogena. Qualcuno pensava di essere Beckenbauer che alza la coppa in cielo, altri, in un sussulto fantozziano, pareva avessero visto San Pietro con le chiavi del paradiso in mano sulla traversa della porta. Napo s’illudeva di intravvedere tra i tifosi la sagoma del padre: paltò grigio, coppola in testa, braccia conserte e bocca cucita. Tutta la squadra sfilava tra una folla di amici e parenti, che gridavano e applaudivano. Erano lì per loro, per sostenerli. Più o meno tutti. Loro, spauriti e superbi, entravano in campo, come la Nazionale di Bearzot ai mondiali contro l’Argentina. Mancava solo l’inno di Mameli.
La partita della domenica era un evento che coinvolgeva l’intero rione, un agglomerato di villette dei primi del Novecento, casermoni popolari del dopoguerra e palazzine residenziali appena costruite dallo IACP per testimoniare l’evoluzione urbanistica e sociale di quello spicchio di metropoli incastrato tra la Bovisa, il ponte della Ghisolfa e il Villapizzone. I tifosi si assiepavano al bordo del campo, sulla fascia laterale; altri occupavano militarmente le panchine di mattoni poste dietro la porta e non sarebbero retrocessi nemmeno di fronte alle pallonate. Genitori, nonni, amici, perfetti sconosciuti costituivano ormai un sodalizio intimo e dissacrante. Sugli spalti si formavano insospettabili amicizie e manifeste ostilità.
Nei momenti di massimo splendore della squadra dell’oratorio, un centinaio di persone capitavano lì da ogni dove per urlare e sbraitare come in un tripudio di campane a Pasqua. L’oratorio era una festa che metteva insieme il diavolo e l’acqua santa. Devoti parrocchiani mondati dai peccati a braccetto con quelli appena usciti dal bar della piazzetta con l’alito che puzzava di bianco spruzzato; ragazzine nello sbocciare della loro bellezza sedevano a fianco di nonnine imbacuccate nei loro scialli a sferruzzare la maglia; grassocci bambini inzaccherati dalla crema che debordava dai bomboloni sgattaiolavano tra le gambe di severe matrone e minute suorine che facevano la spola tra la sala parrocchiale e il refettorio per imbandire la lezione di catechismo del pomeriggio. Puntuale alle tre e mezzo: proprio quando iniziano le partite del campionato.
Davanti al pubblico amico tutta la squadra saltellava per mettere in mostra i quadricipiti tirati a lucido e, mano nella mano, correva una scossa elettrica che odorava di vanità. E solo il fischio d’inizio poteva spezzarla. Anche qui, don Antonio, che aveva indossato i panni dell’arbitro integerrimo senza tuttavia abbandonare la sua lunga tonaca nera, se la prendeva comoda. Forse la tirava per le lunghe per raccogliere consensi e preghiere in campo neutro; forse per devozione verso il campanile che allungava la sua ombra sul terreno di gioco; forse per far incazzare ancora una volta i ragazzi della squadra.
Nella solennità dell’attimo che precedeva il calcio d’inizio sbucava come una zanzara il Nando Martellini, uno stravagante e attempato parrocchiano che, per intrattenere la tribuna infreddolita, faceva il verso al celebre telecronista Rai, sprecando ampollose metafore e inutili iperboli. «Tutto pronto per il fischio d’inizio. Una tensione palpabile corre lungo la schiena dei sessantamila tifosi accorsi qui a San Siro per assistere al match clou che ci vede di fronte alla Ghisolfa: i nostri, in tenuta bianca, attaccano da sinistra a destra; gli avversari, casacca blu e gialla a righe verticali, batteranno il calcio d’inizio.» La sua voce catodica, appena nasale, usciva con enfasi dalle labbra e cresceva progressivamente in un ritmo da curva sud: «Subito le formazioni!» Una pausa millimetrica per richiamare gli Olè del pubblico già in fermento; poi, con uno scatto improvviso: «Napo (Olè); Mille Lire (Olè); Carella (Olè); Mezzo Litro (Olè); la Lecca (Olè); Pezzey (Olè); il Banana (Olèèèèèèèè).» Fischi e applausi venivano giù a dirotto. Il Nando Martellini poteva tirare il fiato e le ragazze potevano zampettare eccitate sulle panchine dietro la porta degli ospiti: per distrarli, dicevano sbattendo le ciglia di sirenette.
Non esistevano nomi e cognomi: ognuno si portava appresso il suo nomignolo come un’onorificenza, al punto che i più fanatici se l’erano fatto cucire sulla maglia dalle loro madri. Napo era il capitano e trascinatore della squadra: un napoletano massiccio e asciutto con un cespuglio di capelli in testa che pareva appunto Napo orso capo, quello dei cartoni animati. Mille Lire, di pura schiatta emiliana, trottava a centrocampo e doveva il suo epiteto alla memoria del padre, buon’anima, che era stato il ritratto sputato di Giuseppe Verdi. Garella, ovviamente, giocava in porta e si muoveva impacciato come un bradipo in mezzo ai pali, né più né meno del mitico portiere del Verona nell’epopea di Schopenhauer Bagnoli. Da qui i compagni di squadra avevano clonato il suo soprannome.
Mezzo Litro invece doveva ringraziare la sua statura per avergli fatto affibbiare quel vezzeggiativo da latteria. Era l’incrocio tra Arnold e “nanu” Galderisi e quando era in forma guizzava da una parte all’altra del campo per imbastire le trame offensive o sgusciare tra le maglie difensive degli avversari. La Lecca giocava in difesa e notoriamente non aveva i piedi buoni. La prima volta che si trovò casualmente un pallone tra i piedi, tirò una sassata contro la traversa che lo fece trasalire: «Minchia che lecca!» E da allora se la porta addosso. Pezzey era il perno centrale della difesa, elegante e arcigno come il suo idolo: Bruno Pezzey, sontuoso stopper della Nazionale austriaca di Hans Krankl, che però veniva puntualmente spernacchiato nello spogliato della parrocchia con facili e maleodoranti accostamenti. Il Banana era l’alter ego di Napo; l’idolo delle ragazzine che si sbracciavano per raccogliere anche solo un suo sguardo; l’icona dei padri che insegnano ai figli i trucchi del pallone: nel suo carniere vantava più fidanzate che gol fatti. Due fattori che dilatavano a dismisura il suo ego. Non si è mai chiarita bene la genesi del suo ambiguo appellativo.
continua
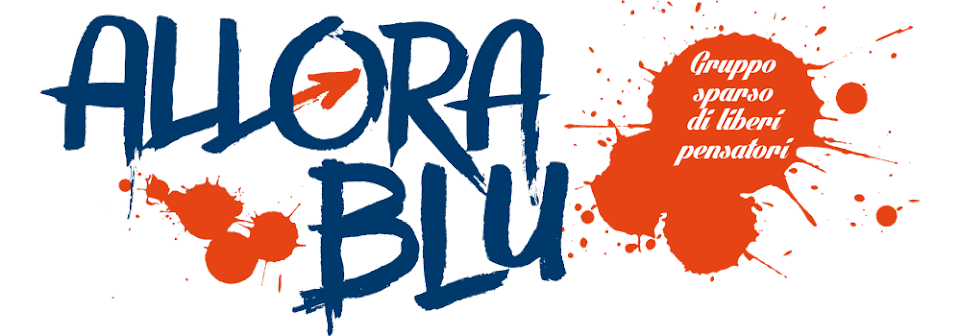

Nessun commento:
Posta un commento