Paolo Rossi era un ragazzo come noi
Nicola Chinellato
Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antognoni, Graziani. Una semplice formazione di calcio? No, amici, questa è una filastrocca rock’n’roll, un’indimenticabile Glory Days bearzottiana, musica pedatoria per l’impresa calcistica più bella di sempre. Riff potenti, crescendo rossiniano ed epica per invincibili.
Spagna 1982. Campioni del Mondo contro ogni pronostico, Campioni contro tutto e contro tutti, Campioni quando il calcio si declamava in versi, poesia della fatica e del genio. C’erano i due punti, i numeri dieci che illuminavano anche se si giocava al buio, le ammonizioni solo se fratturavi una tibia e gli avversari erano leggende in pantaloncini: la Germania Ovest di Rummenigge e Kaltz, il Brasile di Zico e Falcao, l’Argentina di Maradona, la Francia di Platini, la Polonia di Boniek. Non il calcio livellato e muscolare di oggi, tutto tattica e tavolino, popolato da artisti circensi specializzati in tuffi plateali al primo refolo di vento, ma uno sport capace ancora di affabulare, di creare un immaginario collettivo di imprese mitiche, prodezze balistiche, personaggi naif ed eroi senza macchia e senza paura.
A quel mondiale, tra tanti squadroni imbattibili, c’eravamo anche noi, l’Italia di Bearzot, un grande punto di domanda senza risposta a chiosare un recente passato di calcio scommesse ed esclusioni eccellenti (Pruzzo e Beccalossi). Più o meno la stessa squadra del ‘78, blocco Juve, e quel Paolo Rossi a cui il C.T. di Aiello del Friuli non volle rinunciare, nonostante fosse reduce da due anni di squalifica.
Ma cosa andiamo a fare in Spagna, ci chiedevamo tutti, cosa? Parte il primo girone, e le paure e i dubbi diventano realtà. Sfidiamo Polonia, Perù e Camerun, e cioè una formazione forte e due compagini molto folkloristiche e non certo irresistibili. Risultato? Tre pareggi per il rotto della cuffia e un gioco di merda che più di merda non si può. Ci salvano una rete di Bruno Conti (funambolica ala che De Gregori renderà immortale in La leva dalcistica del 1968) e una di Ciccio Graziani, bomber noto ai più per il suo mitico stop a seguire, contraddizione in termini dell’abbecedario calcistico. Andiamo avanti a fatica, tra i lazzi della stampa specializzata, le pernacchie degli avversari e un Paolo Rossi che non vede la porta nemmeno a farlo giocare con il binocolo al collo.
Quel che accadrà dopo, però, ha dell’incredibile, è fantascienza, è il romanzo folle e stralunato di un visionario del calcio, una scheggia impazzita di imprevedibilità pedatoria che sovvertirà il destino apparentemente già scritto del nostro Mundial. E la vita, si sa, non è un lungo fiume tranquillo, piuttosto scorre tortuosa e spumeggiante come un ruscello di montagna, acqua che l’alveo trattiene a stento. Ti alzi al mattino, pensi che ogni cosa vada esattamente come tutti gli altri giorni, e invece accade l’imprevisto, un incontro, una telefonata, una mail, e tanti saluti alla banalità dell’abitudine. Figuriamoci nel calcio, dove la palla è rotonda e talvolta prende traiettorie che nemmeno Dio saprebbe descrivere. Ecco allora, che ci becchiamo Brasile e Argentina, mini-girone all’italiana, passa solo la prima. Ed è un po’ come se a tutta la nazione avessero infilato un cactus nelle mutande: comunque tu ti muova, fai danni. C’è chi parte per il mare e chi rimette nel cassetto il tricolore. È finita, dai, pensiamo alle ferie. Invece al Sarrià di Barcellona si compie il primo miracolo, altro che moltiplicazione dei pani e dei pesci. Giochiamo contro l’Argentina e nella metà campo avversaria ci sono i campioni in carica, Passarella (“dai Daniel Daniel Daniel, tira la bomba, tira la bomba!”), Ardiles, Bertoni e l’extraterrestre Diego Armando Maradona. Fronti imperlate di sudore, respiri affannati, gambe che tremano: ma quando mai vinciamo contro questi qui? A regalarci il sogno pensa Claudio Gentile, italiano delle colonie, sguardo ruvido da camionista e piede rigido come il porfido. “El Pibe De Oro” non vede biglia: Gentile gli si aggrappa alla maglietta, gliela strappa, lavora di anca e di gomiti, gli resta appiccicato anche nell’intervallo, tra bicchieri di integratore salino e una fugace pisciata. Se quello prova a partire in dribbling, volano calcioni sulle caviglie che rimbombano anche nel tubo catodico. Si gioca così in quegli anni: il genio fa il genio e l’operaio ci mette cuore e cattiveria. Segnano Tardelli e Cabrini, rintuzza Passarella nel finale, ma è vinta contro ogni pronostico. L’Italia torna a respirare, tutti insieme, all’unisono, riempiamo le piazze della nostra gioia troppo trattenuta. Si pensa al Brasile, che fa una paura nera, ma dopo aver impacchettato e rispedito al mittente Maradona e i suoi fratelli ci crediamo un po’ di più. È dura, durissima, ma possiamo farcela.
Al Sarrià affrontiamo i verdeoro che hanno appena battuto l’Argentina e che sono una compagine di fenomeni, gente che nel Barcellona di oggi manderebbe Messi in panchina o a lucidare le scarpette: Zico, Junior, Socrates, Falcao, Eder. Hanno una pippa in porta (Valdir Peres) e un gatto di marmo davanti (Serginho), ma gli altri nove stanno al calcio come Giotto alla pittura. Chi non ha visto quella partita non potrà mai capire cosa significhi palpitare veramente. Non un match, ma un thriller alla Hitchcock, cuore in gola e chiappe strettissime. Giocano bene, i brasileiros, ma noi decisamente meglio: Pablito si scatena e ne fa tre, Zoff vola ovunque, Antognoni sembra più brasiliano dei brasiliani, Conti non lo fermi nemmeno se gli spari. Si combatte colpo su colpo: Rossi, Socrates, Rossi, Falcao, Rossi, 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1, 2 a 2, 3 a 2. Partono parecchie coronarie e a fine partita sono pochi coloro che possono dire di avere le mutande intonse. L’arbitro fischia la fine e andiamo a festeggiare in strada, di nuovo tutti insieme, perché tutto è pazzesco, assurdo, è semifinale e ci tocca la Polonia di Boniek, che ha eliminato URSS e Belgio. Ma ormai siamo rilassati, in fondo al cuore lo sappiamo che si va a Madrid, che la finale è nostra. E infatti, in una partita che sembra non avere pathos, Paolo Rossi, che ormai segna di coscia, di culo, di anca, di stinco, di petto e anche di ascella, ne fa due e ci porta per mano fino al Bernabeu.
È la sera della finale e ce la giochiamo con l’immortale Germania, una squadra che non molla mai un centimetro di campo, una palla, un minuto di gioco. Non è il Brasile, ma comunque è fortissima. Da loro, in attacco, c’è Karl Heinz Rummenigge, il giocatore che ho più amato nella mia vita. Non è ancora venuto all’Inter (ci arriverà due anni più tardi) e quindi è un nemico come gli altri. L’Italia peraltro questa volta si veste un po’ più di nerazzurro: giocano Lele Oriali, “Zio” Beppe Bergomi, diciotto anni e due mustacchi da sergente d’artiglieria, e “Spillo” Altobelli, l’analfabeta del goal, che segnerà la terza rete, quella dell’apoteosi.
11 luglio del 1982, giorno della finale. Dopo aver finito la quinta ginnasio, ero partito per le vacanze e mi trovavo a Villasimius, in Sardegna, a casa di amici. Nonostante fossi un ragazzetto di quindici anni, ricordo benissimo ogni secondo della partita, la gioia, i palpiti, il tricolore stretto al petto. Sarà l’emozione sportiva più intensa della mia vita, superiore anche alla Champions vinta dall’Inter dopo 45 anni e a Baldini che domina la maratona ad Atene, nel 2004, entrando da solo nello stadio Olimpico. La voce del grande Nando Martellini, l’arbitro Coehlo (cazzo, questo è brasiliano e ci inculerà), il rigore sbagliato da Cabrini a fine primo tempo (e il bestemmione che fece impallidire mia madre), Rossi che la butta dentro al 56° della ripresa, per la sesta volta, l’urlo liberatorio di Tardelli e di sessanta milioni di italiani, Sandro Pertini che esulta in tribuna, Dino Zoff che alza la coppa, Campioni del Mondo! Campioni del Mondo!, il golfo di Cagliari illuminato a giorno dai fuochi d’artificio, io che abbraccio tutti e mi tuffo in mare vestito, cinque chilometri a piedi all’alba per comprare la Gazzetta dello Sport, senza trovarla. Accecanti bagliori di un ricordo che oggi, a più di trent’anni di distanza, mi riempie ancora il cuore di quella ingenua e fanciullesca felicità, che solo il calcio, e lo sport in genere, riescono a donarmi. E come a Madrid, l’11 luglio del 1982, continuo a sentirmi campione, quasi che aver vinto quella coppa fosse una sorta di decorazione sul campo di cui i posteri si ricorderanno in eterno: guarda lì, quello è Nick, rocker, interista e campione del mondo. Perché chi c’era, chi ha vissuto quel Mundial in prima persona, chi ha palpitato nella canicola estiva delle notti spagnole, sa benissimo di essersela giocata esattamente come ha fatto l’undici azzurro. Ogni partita, ogni minuto, ogni centimetro di campo, come fossimo tutti Paolo Rossi.
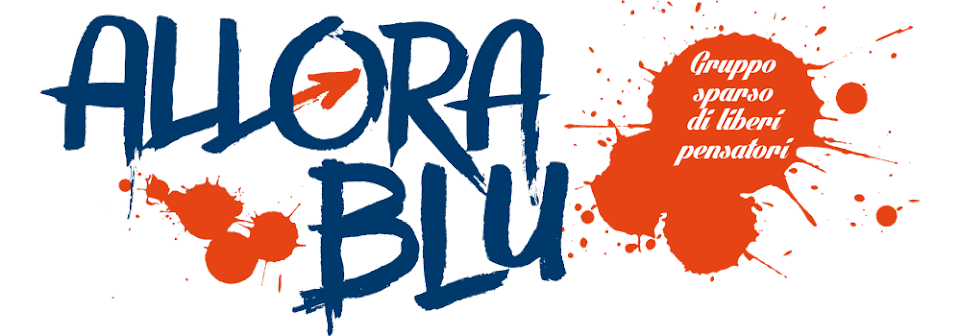

Nessun commento:
Posta un commento